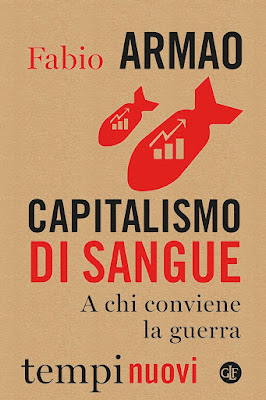Se una Costituzione si può migliorare, significa che
si può anche peggiorare. E’ questo il rischio del presidenzialismo, è questa la
sua sfida
Sono queste le parole che aprono il testo di Ainis ad
indicare che mettere mano a modifiche costituzionali è sempre un passaggio molto
delicato che va affrontato entrando, con serena razionalità e con un inclusivo
sguardo di lungo periodo, nel suo merito a partire dalle motivazioni e dalle
finalità che lo ispirano. A maggior ragione questo vale in tempi, come quelli
attuali, caratterizzati da evidenti sofferenze nel funzionamento delle
“classiche” regole democratiche e quindi sempre più pericolosamente propensi a
soluzioni semplicistiche e sbrigative. In particolare è in questo contesto che si
sta da tempo assistendo al ritorno del “mito del Capo” che, riadattato ai tempi della Rete e dei social, ha assunto secondo
Ainis le sembianze di una più complessiva capocrazia. Questa nuova proposta di modifica della Costituzione italiana, che
ridisegna in particolare la sua Parte Seconda (quella che definisce l’ordinamento della Repubblica) appare ispirata proprio dalla finalità di dare
riconoscimento formale al ruolo del “capo”. (è bene ricordare che la Costituzione Italiana, per
quanto ancora relativamente giovane, gode del poco invidiabile primato di
essere fra quelle più interessate da proposte
di modifica, la maggior parte delle quali comunque naufragate in itinere). E’ dato acquisito. o perlomeno tale dovrebbe essere,
che la Costituzione sia un valore condiviso da tutti, e come tale quindi al di
sopra delle pur legittime visioni di parte. Pertanto le sue sempre possibili
modifiche è bene che non avvengano a “colpi della maggioranza di turno”, L’augurio che tutti dovrebbero condividere e
perseguire è che ciò avvenga anche in questo caso. Fermo restando questo
contesto il dato di partenza su cui riflettere è una proposta che,
faticosamente, ha preso le mosse grazie ad una iniziativa dell’attuale governo
Meloni
sostenuto
dalla coalizione di centrodestra vincitrice delle elezioni del 2021 con il
43,79% dei voti espressi dal 63,91% degli aventi diritto al voto, e quindi in
effetti votato dal 26,7% degli italiani. A sua volta Fratelli d’Italia, il
partito capofila della coalizione, con il suo 25,99% di voti raccolti nella
quota proporzionale è stato scelto dal 18,5%. Sono dati che confermano l’importanza
di acquisire, andando oltre l’interesse di parte, il maggior consenso
trasversale possibile, ripetendo cioè la straordinaria esperienza di unità
nazionale che ha prodotto, con la nascita della Repubblica Italiana, l’attuale
Costituzione del 22 Dicembre 1947
Il programma della coalizione di centrodestra
prevedeva, al punto 3 del programma elettorale vittorioso alle elezioni del
2022, l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, che però, pochi mesi addietro, è stata invece mutata
in una diversa proposta, quella dell’elezione diretta del Capo di Governo, del
Premier. Si tratta, come si
vedrà, di una idea perlomeno originale che, improntata ad una non meglio
precisata idea di “democrazia diretta”, presenta al momento ancora così tanti aspetti incerti e confusi
da avere, a partire dalle stesse forze politiche che la stanno promuovendo, il
carattere di un cantiere in corso. Per quanto quindi ancora suscettibile di cambiamenti,
e sulla base di quanto è sin qui dato di capire, l’idea di fondo che la sta
ispirando è quella dell’introduzione di una forma di democrazia basata sul presidenzialismo, ossia “una particolare forma di governo, uno dei modi con
cui, in una democrazia, avvengono la trasmissione e l’esercizio del potere
distribuendolo fra i vari organi costituzionali”. ciò che caratterizza il presidenzialismo non è tanto
la figura del Presidente in sé, ma l’insieme dei poteri che gli sono attribuiti
nell’ambito dei rapporti con gli altri organi istituzionali. Si tratta cioè di
una architettura del potere che può variare, anche di molto, in relazione alla
diversa modulazione di diversi elementi quali ad esempio: la
durata del mandato, il suo abbinamento a quello del Parlamento, l’età minima e
massima previste per diventare Presidente, la divisione di poteri con gli altri
organi. La nascita del
presidenzialismo coincide di fatto con quella della stessa democrazia a fine
Settecento e nel corso di questi secoli si è sostanzialmente articolato su tre
modelli, il più rilevante dei quali è ancora oggi quello americano, il primo ad
essere stato adottato.
Capocrazia
non è un testo specialistico di diritto costituzionale, non offre quindi una
illustrazione analitica e dettagliata del complesso delle norme che regolano la
struttura del potere, si limita, con taglio divulgativo, a presentare i tratti
essenziali di questi tre modelli con la finalità precipua di meglio capire la
loro eventuale adattabilità alla situazione italiana
 il modello statunitense
=
gli USA (United
States of America), sono, com’è noto, uno
Stato federale, attualmente composto da 50 Stati, che concede loro ampi spazi di autogoverno. E’ ancora oggi l’immutata
eredità delle scelte costituzionali operate dai Padri Fondatori a fine
Settecento all’indomani dell’ottenuta indipendenza dal Regno Unito. La scelta
del presidenzialismo, ossia di una forte figura al vertice della struttura del
potere, si spiega proprio con le caratteristiche degli USA di allora: uno Stato
neonato, privo di una sua consolidata organizzazione centrale, con una classe
politica in gran misura ancora formata da personalità individuali, in impetuoso
e continuo sviluppo. In tale situazione la figura di un Presidente, dotata di
forti poteri, sembrò essere l’unica in grado di tenere insieme, nell’ambito di
un attento bilanciamento dei poteri, efficienza e rapidità decisionale con rappresentatività
elettorale. La Costituzione americana del 1787 prevede infatti che a capo del
governo centrale stia un Presidente, dotato di forti poteri (fra gli
altri, a puro titolo esemplificativo, è
titolare di tutte le funzioni esecutive del governo federale stabilendo le
direttive di politica interna ed estera, nomina tutti i ministri e affida tutti
i più rilevanti incarichi istituzionali, è Comandante in capo delle Forze
Armate)
la cui elezione (con un mandato, rinnovabile una seconda volta, di quattro anni) avviene in
forma indiretta [ogni Stato elegge con criterio maggioritario (chi vince prende
tutti i delegati ad ognuno di essi assegnati), dei rappresentanti, i “grandi
elettori”, che in una seconda votazione eleggono Presidente e
Vice-Presidente]. Il sistema elettorale americano, anch’esso figlio di scelte
settecentesche maturate quindi ben prima dell’avvento delle masse sulla scena
politica, non favorisce più di tanto l’affluenza elettorale (per votare
il cittadino deve fare espressa domanda di iscrizione alle liste elettorali) da sempre quindi
tutt’altro che alta, questo aspetto combinato con le modalità di assegnazione
dei grandi elettori ha da sempre implicato che il Presidente eletto non sia
automaticamente l’espressione della maggioranza dei votanti (esempio
recente è quello del 2016 quando Hillary Clinton ottenne ben 3 milioni di voti
in più di Donald Trump che però, avendo conquistato la maggioranza dei
delegati, vinse le elezioni). Il bilanciamento del poteri presidenziali è assicurato da due
organi: la Corte Suprema
(la
corrispondente della nostra Corte Costituzionale, che è però composta da nove membri nominati a vita
la cui scelta, all’atto delle loro dimissioni, compete allo stesso Presidente
di turno, un aspetto che sbilancia notevolmente la sua obiettività) chiamata ad
esprimersi sulla legittimità costituzionale dei provvedimenti presidenziali e
ad esercitare un forte controllo (tramite la nomina di “commissioni d’indagine”) ed il Congresso (il nostro Parlamento) formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato a cui compete,
oltre alla legislazione ordinaria, la fondamentale approvazione del bilancio di
Stato senza la quale il Presidente perde ogni risorsa spendibile fatta salva la
sola gestione ordinaria delle spese. Un ulteriore bilanciamento è dato dallo
sfalsamento dei turni elettorali, il Congresso viene eletto a metà mandato
presidenziale (elezioni di mid-term) ed è quindi possibile che il Presidente, se non ha ben governato,
non veda confermata la maggioranza che l’ha sostenuto. Va inoltre detto che in
aggiunta a questi bilanciamenti istituzionali il potere giudiziario americano è
molto forte (non esiste ad esempio la nostra “immunità parlamentare”) e molto autonomo (i giudici dei singoli Stati sono eletti dai cittadini) tanto da
giustificare la formula che definisce il sistema americano “government of judges” (governo dei
giudici). In questo quadro normativo, rimasto sostanzialmente immutato per
tutti questi secoli, la storia realmente avvenuta racconta di un Presidente a
lungo non più di tanto vero centro del funzionamento del sistema (salvo
temporanei passaggi come ad esempio la presidenza di Abraham Lincoln) essendo
all’atto concreto sempre stato l’espressione prima dei notabili e poi dei
partiti che ne garantivano l’elezione. E’ solo con la grave crisi del 1929 e la
presidenza di Franklin Delano Roosevelt che si crea un più diretto rapporto tra
Presidente eletto ed elettorato tale da porlo in condizione di prevalere sugli
stessi partiti (di conseguenza da lì in poi sempre più appiattiti su di esso) e di avviare
un aggiustamento della reale struttura di potere ad oggi riducibile ad un
insieme di cerchi concentrici: al centro l’Executive Office, un gabinetto formato dal Presidente e dai suoi più stretti
collaboratori, a cui segue un secondo cerchio costituito dai dipartimenti (quindici,
assimilabili ai nostri ministeri) con al suo esterno un terzo cerchio composto da numerose autorità
indipendenti con funzioni normative e di vigilanza. Una sorta di sistema solare
che ha effettivamente al suo centro il Presidente. Il presidenzialismo
americano esprime quindi un sistema indiscutibilmente democratico (grazie ai
previsti contrappesi) in grado al contempo di esprimere un efficiente decisionismo
presidenzialista (Congresso permettendo). Ma è al tempo stesso evidente che si tratta di un modello che, per
le sue caratteristiche originarie, per le condizioni economiche, sociali e
culturali del paese, per il forte ruolo dei singoli Stati, appare difficilmente
esportabile, così com’è, in altri paesi con differenti storia, cultura,
struttura. Emerge pertanto un primo aspetto di cui tenere conto: nelle faccende costituzionali conta il testo, ma ben
di più il contesto che lo determina e lo interpreta
il modello statunitense
=
gli USA (United
States of America), sono, com’è noto, uno
Stato federale, attualmente composto da 50 Stati, che concede loro ampi spazi di autogoverno. E’ ancora oggi l’immutata
eredità delle scelte costituzionali operate dai Padri Fondatori a fine
Settecento all’indomani dell’ottenuta indipendenza dal Regno Unito. La scelta
del presidenzialismo, ossia di una forte figura al vertice della struttura del
potere, si spiega proprio con le caratteristiche degli USA di allora: uno Stato
neonato, privo di una sua consolidata organizzazione centrale, con una classe
politica in gran misura ancora formata da personalità individuali, in impetuoso
e continuo sviluppo. In tale situazione la figura di un Presidente, dotata di
forti poteri, sembrò essere l’unica in grado di tenere insieme, nell’ambito di
un attento bilanciamento dei poteri, efficienza e rapidità decisionale con rappresentatività
elettorale. La Costituzione americana del 1787 prevede infatti che a capo del
governo centrale stia un Presidente, dotato di forti poteri (fra gli
altri, a puro titolo esemplificativo, è
titolare di tutte le funzioni esecutive del governo federale stabilendo le
direttive di politica interna ed estera, nomina tutti i ministri e affida tutti
i più rilevanti incarichi istituzionali, è Comandante in capo delle Forze
Armate)
la cui elezione (con un mandato, rinnovabile una seconda volta, di quattro anni) avviene in
forma indiretta [ogni Stato elegge con criterio maggioritario (chi vince prende
tutti i delegati ad ognuno di essi assegnati), dei rappresentanti, i “grandi
elettori”, che in una seconda votazione eleggono Presidente e
Vice-Presidente]. Il sistema elettorale americano, anch’esso figlio di scelte
settecentesche maturate quindi ben prima dell’avvento delle masse sulla scena
politica, non favorisce più di tanto l’affluenza elettorale (per votare
il cittadino deve fare espressa domanda di iscrizione alle liste elettorali) da sempre quindi
tutt’altro che alta, questo aspetto combinato con le modalità di assegnazione
dei grandi elettori ha da sempre implicato che il Presidente eletto non sia
automaticamente l’espressione della maggioranza dei votanti (esempio
recente è quello del 2016 quando Hillary Clinton ottenne ben 3 milioni di voti
in più di Donald Trump che però, avendo conquistato la maggioranza dei
delegati, vinse le elezioni). Il bilanciamento del poteri presidenziali è assicurato da due
organi: la Corte Suprema
(la
corrispondente della nostra Corte Costituzionale, che è però composta da nove membri nominati a vita
la cui scelta, all’atto delle loro dimissioni, compete allo stesso Presidente
di turno, un aspetto che sbilancia notevolmente la sua obiettività) chiamata ad
esprimersi sulla legittimità costituzionale dei provvedimenti presidenziali e
ad esercitare un forte controllo (tramite la nomina di “commissioni d’indagine”) ed il Congresso (il nostro Parlamento) formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato a cui compete,
oltre alla legislazione ordinaria, la fondamentale approvazione del bilancio di
Stato senza la quale il Presidente perde ogni risorsa spendibile fatta salva la
sola gestione ordinaria delle spese. Un ulteriore bilanciamento è dato dallo
sfalsamento dei turni elettorali, il Congresso viene eletto a metà mandato
presidenziale (elezioni di mid-term) ed è quindi possibile che il Presidente, se non ha ben governato,
non veda confermata la maggioranza che l’ha sostenuto. Va inoltre detto che in
aggiunta a questi bilanciamenti istituzionali il potere giudiziario americano è
molto forte (non esiste ad esempio la nostra “immunità parlamentare”) e molto autonomo (i giudici dei singoli Stati sono eletti dai cittadini) tanto da
giustificare la formula che definisce il sistema americano “government of judges” (governo dei
giudici). In questo quadro normativo, rimasto sostanzialmente immutato per
tutti questi secoli, la storia realmente avvenuta racconta di un Presidente a
lungo non più di tanto vero centro del funzionamento del sistema (salvo
temporanei passaggi come ad esempio la presidenza di Abraham Lincoln) essendo
all’atto concreto sempre stato l’espressione prima dei notabili e poi dei
partiti che ne garantivano l’elezione. E’ solo con la grave crisi del 1929 e la
presidenza di Franklin Delano Roosevelt che si crea un più diretto rapporto tra
Presidente eletto ed elettorato tale da porlo in condizione di prevalere sugli
stessi partiti (di conseguenza da lì in poi sempre più appiattiti su di esso) e di avviare
un aggiustamento della reale struttura di potere ad oggi riducibile ad un
insieme di cerchi concentrici: al centro l’Executive Office, un gabinetto formato dal Presidente e dai suoi più stretti
collaboratori, a cui segue un secondo cerchio costituito dai dipartimenti (quindici,
assimilabili ai nostri ministeri) con al suo esterno un terzo cerchio composto da numerose autorità
indipendenti con funzioni normative e di vigilanza. Una sorta di sistema solare
che ha effettivamente al suo centro il Presidente. Il presidenzialismo
americano esprime quindi un sistema indiscutibilmente democratico (grazie ai
previsti contrappesi) in grado al contempo di esprimere un efficiente decisionismo
presidenzialista (Congresso permettendo). Ma è al tempo stesso evidente che si tratta di un modello che, per
le sue caratteristiche originarie, per le condizioni economiche, sociali e
culturali del paese, per il forte ruolo dei singoli Stati, appare difficilmente
esportabile, così com’è, in altri paesi con differenti storia, cultura,
struttura. Emerge pertanto un primo aspetto di cui tenere conto: nelle faccende costituzionali conta il testo, ma ben
di più il contesto che lo determina e lo interpreta
 il modello francese = Prende forma
due
secoli dopo, nel 1958, quando il Generale De Gaulle, l’eroe della guerra di
liberazione dall’occupazione nazista, venne richiamato al governo per far
uscire la Francia dalla gravissima crisi algerina (la lotta di liberazione della ex colonia e la reazione, al limite
del colpo di stato, di una parte dell’esercito francese). De Gaulle
accettò l’incarico a fronte di una modifica costituzionale espressamene
richiesta proprio per avere un ampio margine di comando (preparata in
tempi molti brevi e senza dibattito parlamentare, ma sancita da un plebiscito
che l’approvò con l’80% dei voti) che di fatto pose fine alla centralità del Parlamento rafforzando
di molto i poteri del Governo e del Presidente e dando così avvio alla V Repubblica francese. Una svolta
radicale che trovò la sua giustificazione, ed il necessario consenso
elettorale, nella urgente necessità di mettere fine all’incapacità del “regime dei
partiti”
di gestire una crisi drammatica e che vide il suo compimento, quattro anni dopo
nel 1962, quando un secondo referendum sancì anche la collegata elezione
diretta del Presidente della Repubblica. Per quanto questa soluzione
costituzionale (adottata da altri paesi nel mondo, in Europa lo ha fatto ad
esempio il Portogallo) sia passata alla storia con il nome di “semipresidenzialismo” a conti
fatti rappresenta al contrario un “super-presidenzialismo”, il
Presidente francese ha infatti molti più poteri del collega americano, può ad
esempio sciogliere a sua discrezione il Parlamento, può approvare leggi senza
il voto parlamentare (come fatto da Macron con la contestata legge sulle pensioni del
marzo 2023) ovvero può convocare referendum per far approvare le sue scelte se
contrastate dal Parlamento, ed in più nomina direttamente il Primo Ministro che
può, a sua discrezione, sfiduciare. Oltretutto, diversamente dagli USA, la sua
elezione, grazie ad una terza riforma costituzionale, avvenuta nel 2000,
coincide con quella del Parlamento e ciò, nel caso di duplice vittoria
elettorale, rafforza vieppiù i suoi margini di manovra. Si è in sostanza di
fronte ad un quadro costituzionale decisamente sbilanciato, eppure la storia
attesta che non c’è stata, fin qui, alcuna svolta autoritaria come per molti
versi sarebbe anche lecito immaginare. La spiegazione consiste, a giudizio
concorde di storici e costituzionalisti, nel fortissimo legame che
il popolo francese, con l’intera sua classe politica, ha con la democrazia nata
con la Rivoluzione Francese di fine Settecento. Consiste in
questo aspetto una seconda rilevante indicazione ….. la
democrazia può vestirsi con varie forme di governo, ma per sopravvivere ha
bisogno di un popolo che la sostenga, che le voglia bene ….
il modello francese = Prende forma
due
secoli dopo, nel 1958, quando il Generale De Gaulle, l’eroe della guerra di
liberazione dall’occupazione nazista, venne richiamato al governo per far
uscire la Francia dalla gravissima crisi algerina (la lotta di liberazione della ex colonia e la reazione, al limite
del colpo di stato, di una parte dell’esercito francese). De Gaulle
accettò l’incarico a fronte di una modifica costituzionale espressamene
richiesta proprio per avere un ampio margine di comando (preparata in
tempi molti brevi e senza dibattito parlamentare, ma sancita da un plebiscito
che l’approvò con l’80% dei voti) che di fatto pose fine alla centralità del Parlamento rafforzando
di molto i poteri del Governo e del Presidente e dando così avvio alla V Repubblica francese. Una svolta
radicale che trovò la sua giustificazione, ed il necessario consenso
elettorale, nella urgente necessità di mettere fine all’incapacità del “regime dei
partiti”
di gestire una crisi drammatica e che vide il suo compimento, quattro anni dopo
nel 1962, quando un secondo referendum sancì anche la collegata elezione
diretta del Presidente della Repubblica. Per quanto questa soluzione
costituzionale (adottata da altri paesi nel mondo, in Europa lo ha fatto ad
esempio il Portogallo) sia passata alla storia con il nome di “semipresidenzialismo” a conti
fatti rappresenta al contrario un “super-presidenzialismo”, il
Presidente francese ha infatti molti più poteri del collega americano, può ad
esempio sciogliere a sua discrezione il Parlamento, può approvare leggi senza
il voto parlamentare (come fatto da Macron con la contestata legge sulle pensioni del
marzo 2023) ovvero può convocare referendum per far approvare le sue scelte se
contrastate dal Parlamento, ed in più nomina direttamente il Primo Ministro che
può, a sua discrezione, sfiduciare. Oltretutto, diversamente dagli USA, la sua
elezione, grazie ad una terza riforma costituzionale, avvenuta nel 2000,
coincide con quella del Parlamento e ciò, nel caso di duplice vittoria
elettorale, rafforza vieppiù i suoi margini di manovra. Si è in sostanza di
fronte ad un quadro costituzionale decisamente sbilanciato, eppure la storia
attesta che non c’è stata, fin qui, alcuna svolta autoritaria come per molti
versi sarebbe anche lecito immaginare. La spiegazione consiste, a giudizio
concorde di storici e costituzionalisti, nel fortissimo legame che
il popolo francese, con l’intera sua classe politica, ha con la democrazia nata
con la Rivoluzione Francese di fine Settecento. Consiste in
questo aspetto una seconda rilevante indicazione ….. la
democrazia può vestirsi con varie forme di governo, ma per sopravvivere ha
bisogno di un popolo che la sostenga, che le voglia bene ….
 il brevetto israeliano =
è forse il modello di presidenzialismo che di più offre spunti di riflessione per
il caso italiano. Innanzitutto perché introduce una variante, del tutto
coerente con la visione di un Presidente eletto direttamente dal popolo, anche
se in questo caso chi viene scelto dal voto popolare non è il Presidente della
Repubblica, ma il Capo del Governo, il Premier (da qui il termine di “premierato”).
Nulla cambia in effetti: passando alla situazione italiana il vero titolo
formale di quello che la vulgata chiama Primo Ministro è “Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Tornando all’esperienza israeliana, l’unica finora ad aver sperimentato
l’elezione diretta del Capo del Governo, va constatato che si è trattato di una
svolta costituzionale (anche se Israele non ha un vero e proprio testo
costituzionale, che è di fatto composto da più distinte “Leggi
fondamentali”) avvenuta nel 1992 (ispirata dall’allora primo Ministro Yitzhak
Rabin, assassinato nel 1995 da un estremista di destra
proprio per il suo ruolo riformatore). La necessità di un rafforzamento dell’esecutivo
era determinata dall’esistenza di una legge elettorale fortemente proporzionale
(ancora oggi basta l’1,5% dei voti per entrare nella Knesset,
il Parlamento israeliano) giustificata dalle stesse caratteristiche di
nascita dello Stato d’Israele. Inevitabile che tale frantumazione del quadro
politico producesse una ingestibile instabilità politica determinata da governi
quasi sempre nati da fragili coalizioni post voto (un aspetto ancora oggi presente).
Il presidenzialismo israeliano (premierato)
venne quindi adottato con la finalità di assegnare ad un Premier forti poteri
in grado quindi di stabilizzare l’azione governativa. Consegnava quindi al
Primo Ministro il fondamentale potere di sciogliere la Knesset, di essere di
fatto il regista unico della formazione del governo e delle sue politiche, restando
però sempre vincolato ad essere formalmente nominato anche da un voto di
fiducia da parte della Knesset. Questo
aspetto ha implicato il mantenimento, stante la frammentazione parlamentare, di
complicate trattative per la formazione di maggioranze parlamentari nelle quali
anche i piccoli partiti mantenevano un forte potere di ricatto (Benjamin
Netanyahu, il primo premier eletto nel 1996 con questo sistema, subì nel corso
dell’unica legislatura basata sulla elezione diretta del Premier ben 63 voti di
sfiducia!). Nel 2001, cinque anni dopo la svolta
costituzionale del 1996, a fronte del totale insuccesso dell’esperienza concreta
la Knesset ha abolito il sistema dell’elezione
diretta del Presidente del Governo. Il percorso tormentato di questo terzo modello
presidenzialista, nato e morto per ragioni strettamente connesse alla particolare
situazione partitica israeliana, offre un ulteriore terzo decisivo elemento di
riflessione: l’architettura
costituzionale è sempre e ovunque una costruzione così complessa e fragile da subordinare
l’introduzione di elementi di modifica per quanto parziali alla conservazione
dell’equilibrio complessivo del quadro costituzionale
il brevetto israeliano =
è forse il modello di presidenzialismo che di più offre spunti di riflessione per
il caso italiano. Innanzitutto perché introduce una variante, del tutto
coerente con la visione di un Presidente eletto direttamente dal popolo, anche
se in questo caso chi viene scelto dal voto popolare non è il Presidente della
Repubblica, ma il Capo del Governo, il Premier (da qui il termine di “premierato”).
Nulla cambia in effetti: passando alla situazione italiana il vero titolo
formale di quello che la vulgata chiama Primo Ministro è “Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Tornando all’esperienza israeliana, l’unica finora ad aver sperimentato
l’elezione diretta del Capo del Governo, va constatato che si è trattato di una
svolta costituzionale (anche se Israele non ha un vero e proprio testo
costituzionale, che è di fatto composto da più distinte “Leggi
fondamentali”) avvenuta nel 1992 (ispirata dall’allora primo Ministro Yitzhak
Rabin, assassinato nel 1995 da un estremista di destra
proprio per il suo ruolo riformatore). La necessità di un rafforzamento dell’esecutivo
era determinata dall’esistenza di una legge elettorale fortemente proporzionale
(ancora oggi basta l’1,5% dei voti per entrare nella Knesset,
il Parlamento israeliano) giustificata dalle stesse caratteristiche di
nascita dello Stato d’Israele. Inevitabile che tale frantumazione del quadro
politico producesse una ingestibile instabilità politica determinata da governi
quasi sempre nati da fragili coalizioni post voto (un aspetto ancora oggi presente).
Il presidenzialismo israeliano (premierato)
venne quindi adottato con la finalità di assegnare ad un Premier forti poteri
in grado quindi di stabilizzare l’azione governativa. Consegnava quindi al
Primo Ministro il fondamentale potere di sciogliere la Knesset, di essere di
fatto il regista unico della formazione del governo e delle sue politiche, restando
però sempre vincolato ad essere formalmente nominato anche da un voto di
fiducia da parte della Knesset. Questo
aspetto ha implicato il mantenimento, stante la frammentazione parlamentare, di
complicate trattative per la formazione di maggioranze parlamentari nelle quali
anche i piccoli partiti mantenevano un forte potere di ricatto (Benjamin
Netanyahu, il primo premier eletto nel 1996 con questo sistema, subì nel corso
dell’unica legislatura basata sulla elezione diretta del Premier ben 63 voti di
sfiducia!). Nel 2001, cinque anni dopo la svolta
costituzionale del 1996, a fronte del totale insuccesso dell’esperienza concreta
la Knesset ha abolito il sistema dell’elezione
diretta del Presidente del Governo. Il percorso tormentato di questo terzo modello
presidenzialista, nato e morto per ragioni strettamente connesse alla particolare
situazione partitica israeliana, offre un ulteriore terzo decisivo elemento di
riflessione: l’architettura
costituzionale è sempre e ovunque una costruzione così complessa e fragile da subordinare
l’introduzione di elementi di modifica per quanto parziali alla conservazione
dell’equilibrio complessivo del quadro costituzionale
Ferma restando l’importanza delle indicazioni fornite da questi
tre modelli di presidenzialismo è doveroso riconoscere che il tema del
rafforzamento del potere esecutivo, anche con il ricorso all’elezione diretta
del suo Capo, è da tempo presente nel dibattito in campo accademico e politico.
Nel primo è stata rilevante la convinzione teorica, determinata dal frequente continuo
valzer di Primi Ministri nel corso della stessa legislatura, del giurista Serio
Galeotti (1922-2000) sulla necessità di abbinare, con due votazioni simultanee,
l’elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento, creando così le
condizioni per cui se cade il primo
decade anche il secondo. A cavallo dei due campi si colloca la stagione
referendaria (1991-1993, che in particolare introduce l’elezione diretta dei
Sindaci e dei Presidenti delle allora Province ) promossa da Mario Segni che ha, introducendo il sistema
maggioritario, avviato la cosiddetta “seconda Repubblica” (per quanto
paradossalmente sempre retta dalla Costituzione della Prima). Segni è stato il principale ispiratore dell’idea politica (che al tempo
raccolse consensi trasversali) di
un legame più stretto tra Premier ed elettori, sintetizzata nello slogan del “Sindaco d’Italia”
(ancora
nel 2022 l’hanno sostenuta Azione ed Italia Viva). E’ però oggettivamente, una soluzione istituzionale sgrammaticata
perché un conto è governare un paese, una città, persino una Regione, tutt’altro
quello di guidare un governo nazionale. L’insieme di queste esperienze suona
come ulteriore richiamo a quanto dedotto dalla vicenda israeliana: le istituzioni
sono un sistema di vasi comunicanti, non è possibile alterare la fisionomia di
un organo senza produrre effetti su tutti gli altri.
In questo
senso non si può non rilevare che l’esperienza di Sindaci e Presidenti di
Regione (la cui elezione diretta è stata introdotta, sulla scia di quella dei
Sindaci, nel 1999) resi più forti grazie alla loro elezione diretta ha
inevitabilmente sminuito il ruolo dei Consigli Comunali e Regionali.
Sono questi i principali presupposti su cui basare la valutazione
della proposta in itinere di presidenzialismo portata avanti dalla Ministra per
le Riforme Istituzionali Alberti Casellati. Che ha, come si è già evidenziato, visto
una prima clamorosa svolta con il passaggio dall’elezione diretta del
Presidente della Repubblica a quella del Premier
a giudizio di
molti ciò è avvenuto per evitare che l’adozione di un presidenzialismo
all’americana o alla francese implicasse l’uscita dal Colle di Sergio Mattarella,
passaggio molto impopolare. Meglio passare alla soluzione israeliana per quanto
malandata e già terminata, certo che, se così fosse, diventa lecito dubitare
della consistenza teorica dell’intero impianto riformista.
Ciò premesso e sempre tenendo in conto che si è di fronte ad un
cantiere in corso con possibili ripensamenti e aggiustamenti, anche sostanziali
per quanto è stato dato di conoscere finora, lascia intendere una proposta, contenuta
nel disegno di legge approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 Novembre
2023, di fatto una sorta di miscela tra l’idea del “Sindaco d’Italia” e quella
del Premierato israeliano, articolata su:
 elezione diretta, ogni cinque anni, del Premier
(al
momento è incerta la dirimente collegata attribuzione di un premio di
maggioranza alla coalizione/partito che lo sostiene)
elezione diretta, ogni cinque anni, del Premier
(al
momento è incerta la dirimente collegata attribuzione di un premio di
maggioranza alla coalizione/partito che lo sostiene)
 adozione di una norma anti-ribaltone, (già
modificata rispetto alle prime ipotesi) in base alla quale il premier può
dimissionarsi (a fronte della manifesta perdita della maggioranza parlamentare) venendo però
sostituito da altro membro della stessa maggioranza che l’ha sostenuto. Ove ciò
non avvenisse si andrebbe a nuove elezioni.
adozione di una norma anti-ribaltone, (già
modificata rispetto alle prime ipotesi) in base alla quale il premier può
dimissionarsi (a fronte della manifesta perdita della maggioranza parlamentare) venendo però
sostituito da altro membro della stessa maggioranza che l’ha sostenuto. Ove ciò
non avvenisse si andrebbe a nuove elezioni.
Impossibile per ora entrare più di tanto nel merito di un testo in
corso di definizione, e d’altronde i tempi della sua approvazione saranno così
lunghi da consentire a tutti una giusta disamina della stesura definitiva,
Ainis si limita pertanto ad indicare i passaggi più dirimenti:
 il ruolo del
Capo dello Stato nel nuovo quadro istituzionale
il ruolo del
Capo dello Stato nel nuovo quadro istituzionale
 i poteri
conferiti al Premier eletto direttamente dal popolo
i poteri
conferiti al Premier eletto direttamente dal popolo
 il rispetto
della sentenza della Corte Costituzionale n° 1146 del1988 che dichiara che “le leggi di revisione costituzionale non possono
offendere i principi supremi della Carta”
il rispetto
della sentenza della Corte Costituzionale n° 1146 del1988 che dichiara che “le leggi di revisione costituzionale non possono
offendere i principi supremi della Carta”
 la gestione
del referendum approvativo (che sicuramente si terrà) sperando che sappia entrare
correttamente nel merito formulando i quesiti su cui esprimersi nel modo più
chiaro possibile onde evitare storture strumentali
la gestione
del referendum approvativo (che sicuramente si terrà) sperando che sappia entrare
correttamente nel merito formulando i quesiti su cui esprimersi nel modo più
chiaro possibile onde evitare storture strumentali
Come ulteriore contributo alla personale formazione di un giudizio
di merito indica quelli che ritiene siano gli elementi su cui si fonda la
disamina dei vizi e delle virtù del Presidenzialismo, vale a dire la sua
relazione/incidenza su:
 stabilità del quadro istituzionale
=
nel contesto di una democrazia parlamentare di norma l’unico organo che non ha
un orizzonte temporale definito è l’esecutivo, può infatti durare l’intera
durata legislativa, ma può anche terminare e mutare ben prima e più volte (l’Italia ne
è un desolante esempio, basti pensare alla tornata 2018-2022 che ha visto
succedersi un governo giallo-verde, uno opposto giallo-rosso, ed uno tecnico di
terzietà), in relazione al mutare delle maggioranze parlamentari. In questo
senso il Presidenzialismo dovrebbe teoricamente garantire, sulla base del
mandato popolare, la copertura dell’intera durata legislativa, ma è pur
altrettanto vero che la stabilità, di per sé stessa, non può essere un valore così
dirimente (le
dittature vantano una grande, ma negativa, stabilità), e comunque non
può essere determinata dalla sola continuità delle persone elette, semmai
quello che dovrebbe essere stabile, per produrre ricadute positive sull’azione
del governo, è l’indirizzo politico degli obiettivi di lungo periodo. I critici
del Presidenzialismo evidenziano che il suo tratto saliente non consiste tanto nella
potenziale stabilità, ma nel rischio, opposto, di eccessiva rigidità, la virtù di un buon sistema di governo è infatti quella di una
virtuosa flessibilità, ossia la
capacità di rimodularsi in relazione al mutare del contesto socio-economico si
cui è chiamato ad intervenire
stabilità del quadro istituzionale
=
nel contesto di una democrazia parlamentare di norma l’unico organo che non ha
un orizzonte temporale definito è l’esecutivo, può infatti durare l’intera
durata legislativa, ma può anche terminare e mutare ben prima e più volte (l’Italia ne
è un desolante esempio, basti pensare alla tornata 2018-2022 che ha visto
succedersi un governo giallo-verde, uno opposto giallo-rosso, ed uno tecnico di
terzietà), in relazione al mutare delle maggioranze parlamentari. In questo
senso il Presidenzialismo dovrebbe teoricamente garantire, sulla base del
mandato popolare, la copertura dell’intera durata legislativa, ma è pur
altrettanto vero che la stabilità, di per sé stessa, non può essere un valore così
dirimente (le
dittature vantano una grande, ma negativa, stabilità), e comunque non
può essere determinata dalla sola continuità delle persone elette, semmai
quello che dovrebbe essere stabile, per produrre ricadute positive sull’azione
del governo, è l’indirizzo politico degli obiettivi di lungo periodo. I critici
del Presidenzialismo evidenziano che il suo tratto saliente non consiste tanto nella
potenziale stabilità, ma nel rischio, opposto, di eccessiva rigidità, la virtù di un buon sistema di governo è infatti quella di una
virtuosa flessibilità, ossia la
capacità di rimodularsi in relazione al mutare del contesto socio-economico si
cui è chiamato ad intervenire
 l’efficienza governativa =
è una diretta conseguenza della stabilità ulteriormente garantita dal fatto che
con il Presidenzialismo il programma da realizzare non è frutto delle
trattative post voto fra le forze che in Parlamento sono chiamate a sostenere
il Capo eletto, tutto ciò dovrebbe essere già avvenuto in precedenza con la
scelta di indicare il Presidente/Premier e di formare, attorno al suo nome, una
coalizione. Un dubbio, non solo ipotetico, nasce dal sempre possibile guastarsi
del rapporto tra Premier e coalizione
l’efficienza governativa =
è una diretta conseguenza della stabilità ulteriormente garantita dal fatto che
con il Presidenzialismo il programma da realizzare non è frutto delle
trattative post voto fra le forze che in Parlamento sono chiamate a sostenere
il Capo eletto, tutto ciò dovrebbe essere già avvenuto in precedenza con la
scelta di indicare il Presidente/Premier e di formare, attorno al suo nome, una
coalizione. Un dubbio, non solo ipotetico, nasce dal sempre possibile guastarsi
del rapporto tra Premier e coalizione
 la sovranità popolare =
“Appartiene al popolo” recita il
primo Articolo delle Costituzione Italiana, così come molte altre nel mondo. Il
Presidenzialismo, soprattutto se rafforzato dal congiunto doppio voto di
Presidente/Premier e del Parlamento, dovrebbe rispettare due volte questa
indicazione. Il diavolo potrebbe però nascondersi nel dettaglio, che tale in
effetti non è, della reale coerenza politica fra questi due voti
la sovranità popolare =
“Appartiene al popolo” recita il
primo Articolo delle Costituzione Italiana, così come molte altre nel mondo. Il
Presidenzialismo, soprattutto se rafforzato dal congiunto doppio voto di
Presidente/Premier e del Parlamento, dovrebbe rispettare due volte questa
indicazione. Il diavolo potrebbe però nascondersi nel dettaglio, che tale in
effetti non è, della reale coerenza politica fra questi due voti
 il sistema delle garanzie =
in tutte le democrazie si basa sulla separazione dei poteri. In particolare
vale, in aggiunta a quello ineliminabile della piena autonomia del potere
giudiziario, quella tra potere legislativo (leggasi Parlamento)
e potere esecutivo (leggasi Governo). Il
Presidenzialismo che prevede due organi elettivi (Presidente/Premier e Parlamento)
di pari dignità in quanto a legittimazione data loro dal voto popolare dovrebbe
essere un rafforzamento del sistema delle garanzie. Molto dipende da come le
norme regolano il rapporto tra i due poteri: chi prevale dove, quando e come
il sistema delle garanzie =
in tutte le democrazie si basa sulla separazione dei poteri. In particolare
vale, in aggiunta a quello ineliminabile della piena autonomia del potere
giudiziario, quella tra potere legislativo (leggasi Parlamento)
e potere esecutivo (leggasi Governo). Il
Presidenzialismo che prevede due organi elettivi (Presidente/Premier e Parlamento)
di pari dignità in quanto a legittimazione data loro dal voto popolare dovrebbe
essere un rafforzamento del sistema delle garanzie. Molto dipende da come le
norme regolano il rapporto tra i due poteri: chi prevale dove, quando e come
 il sistema dei controlli =
discende da quello precedente delle garanzie e, con il Presidenzialismo,
dovrebbe avere un importante rafforzamento soprattutto se viene garantito che
il controllo parlamentare sull’attività dell’esecutivo non metta a repentaglio
l’esistenza stessa del controllore. Fuor di metafora è ciò che succede nei
Comuni in Italia: il Consiglio Comunale può rimuovere Sindaco e Giunta con una
mozione di sfiducia, ma a questo punto decade anch’esso. Potrebbe allora essere
reale il rischio (ben conoscendo la scarsa voglia di andare a casa
della classe politica) che per sopravvivere (meglio tirare a campare che tirare le cuoia)
venga a decadere il controllo stesso
il sistema dei controlli =
discende da quello precedente delle garanzie e, con il Presidenzialismo,
dovrebbe avere un importante rafforzamento soprattutto se viene garantito che
il controllo parlamentare sull’attività dell’esecutivo non metta a repentaglio
l’esistenza stessa del controllore. Fuor di metafora è ciò che succede nei
Comuni in Italia: il Consiglio Comunale può rimuovere Sindaco e Giunta con una
mozione di sfiducia, ma a questo punto decade anch’esso. Potrebbe allora essere
reale il rischio (ben conoscendo la scarsa voglia di andare a casa
della classe politica) che per sopravvivere (meglio tirare a campare che tirare le cuoia)
venga a decadere il controllo stesso
 la responsabilità = la vera essenza
della democrazia rappresentativa che consegna ai governati
la possibilità di decidere (ed il giorno del giudizio è quello delle
elezioni sull’azione dei governanti in quanto “responsabili” del loro agire. La maggior virtù del
Presidenzialismo consiste proprio nel fatto che, con l’elezione del
Presidente/Premier, l’individuazione delle responsabilità è automatica. Una
virtù che rischia però di essere macchiata dal possibile rimpallarsi tra
Presidente/Premier e maggioranza parlamentare di sostegno, e comunque di
impallidirsi nell’eventuale secondo mandato
la responsabilità = la vera essenza
della democrazia rappresentativa che consegna ai governati
la possibilità di decidere (ed il giorno del giudizio è quello delle
elezioni sull’azione dei governanti in quanto “responsabili” del loro agire. La maggior virtù del
Presidenzialismo consiste proprio nel fatto che, con l’elezione del
Presidente/Premier, l’individuazione delle responsabilità è automatica. Una
virtù che rischia però di essere macchiata dal possibile rimpallarsi tra
Presidente/Premier e maggioranza parlamentare di sostegno, e comunque di
impallidirsi nell’eventuale secondo mandato
 la modernità = se e vero che,
come si è visto, il Presidenzialismo compie ormai ben più di due secoli, è però
altrettanto vero (ed è un prezioso indicatore dell’attuale preoccupante
stato di salute della democrazia) che negli ultimi cinquant’anni quasi tutte le
nuove democrazie sorte nel mondo sono imperniate su un Presidenzialismo spesso
dotato di forti poteri …. è
un vento forte quello che sta soffiando e, a quanto pare, spazza via ogni
resistenza per quanto fondata questa possa essere
……..
la modernità = se e vero che,
come si è visto, il Presidenzialismo compie ormai ben più di due secoli, è però
altrettanto vero (ed è un prezioso indicatore dell’attuale preoccupante
stato di salute della democrazia) che negli ultimi cinquant’anni quasi tutte le
nuove democrazie sorte nel mondo sono imperniate su un Presidenzialismo spesso
dotato di forti poteri …. è
un vento forte quello che sta soffiando e, a quanto pare, spazza via ogni
resistenza per quanto fondata questa possa essere
……..
Ainis
articola nei successivi capitoli una ricostruzione dei conflitti politici già
avvenuti nel corso dei quasi ottant’anni di vita della Repubblica Italiana
attorno al tema del rafforzamento dell’esecutivo ed una valutazione “tecnica”
delle riforme costituzionali già intervenute e di quelle fallite o bocciate in
sede di referendum. In coerenza con la nostra premessa non sono qui
sintetizzati, per quanto di indubbio interesse, perché non immediatamente
connessi alla finalità di questa Parola del mese
Nella parte finale del saggio ritorna prepotentemente sulla scena
il termine che ha dato spunto a questa riflessione: capocrazia. L’intera discussione
sul Presidenzialismo, ed in particolare sulla sua versione di Premierato, non
può non tenere conto di un decisivo dato di fatto: ben prima che una versione
formale di Presidenzialismo sia attuata anche in Italia si è, da tempo,
chiamati a fare i conti con un evidente “Presidenzialismo di fatto”, una innegabile
concentrazione di potere verso l’alto che ormai da decenni caratterizza il
concreto gioco politico italiano. Una riforma
presidenzialista può essere anche tacita, inespressa, informale, ed ha per
l’appunto come nome: capocrazia. All’interno di un più generale, e
più complesso, riaffacciarsi della figura dell’ “uomo (donna) solo al comando”
(fenomeno che, coerente completamento dell’individualismo
neoliberista, richiederebbe una dettagliata analisi a sé stante) Ainis, da costituzionalista, concentra la sua attenzione sui
passaggi che, nella recente storia politica e istituzionale, di più testimoniano
questa evoluzione. A partire dalla incongruenza nominalistica che vede nascere
negli anni Novanta quella che è ormai passata alla storia come “Seconda
Repubblica”, per quanto ancora si reggesse sulla Costituzione della “Prima Repubblica”
(anomalia che verrebbe sanata solo con la nascita di una “Terza Repubblica”, ad esempio quella determinata
proprio dalla riforma presidenzialistica
se davvero attuata, questo è imposto da
un minimo di coerenza nominalistica, non a caso in Francia dove la costituzione
è stata variata cinque volte sono arrivati alla “Quinta Repubblica”). Ma al di là dei termini distorti appare evidente che sono
profonde le differenze fra i contesti politici delle due Repubbliche italiane:
nella Prima i voti degli italiani erano espressi guardando ai partiti, certo i
loro leader potevano aggiungere un certo richiamo, ma i manifesti elettorali
riportavano solo simboli e nomi di partiti. Nella Seconda il simbolo, quasi
sempre modificato, migra sul fondo e viene coperto dal nome del leader, che
spesso diventa il nome stesso del partito ormai reso ad esso subalterno
…. a puro
titolo di memoria storica, perché quelli attuali ancora troneggiano, vanno
ricordate ad esempio le liste: Segni, Pannella, Dini, Di Pietro, Bonino ….
Una evoluzione che viene sancita dalla terminologia usata nella
Legge Elettorale del 2005, dove il termine “Capo” è introdotto in modo esplicito ( …… Capo della forza politica,
unico Capo della coalizione …., recuperando così un termine in precedenza
usato soltanto nella mussoliniana Legge 2263 del 1925) per definire “Capo del Governo” quello che fin lì era il Presidente
del Consiglio. Va poi constatato che anche i partiti/movimenti che hanno
conservato il riferimento esclusivo a simbolo e nome della lista non sono,
nella pratica concreta seppure con diversa accentuazione, sfuggiti a questa metamorfosi
del rapporto fra vertice e base.
il Movimento
5 Stelle convoca nel 2017 primarie online per eleggere il suo “Capo politico”, espressione ripetuta per 17 volte
nei 7 articoli del regolamento di voto, il Partito Democratico ha da sempre una
consolidata storia di forte concentrazione di potere nella figura del suo
Segretario che, oltre ad essere automaticamente candidato premier, esprime la
linea, gestisce il simbolo, decide le liste elettorali. Altri ancora, come
Forza Italia e Fratelli d’Italia, hanno ipocritamente mascherato la fortissima
concentrazione del potere nella figura del loro Capo, ancora definendolo Presidente
La capocrazia
italiana non si esprime solo sulla scena nazionale, ma si accentua persino in
quella locale e regionale. Come già evidenziato in precedenza l’elezione
diretta dei Sindaci (Legge 81 del 1993)
e dei Presidenti di Regione (Legge Costituzionale 1 del 1999) ha affidato loro ampi poteri che hanno sminuito di molto l’azione
dei Consigli Comunali e dei Consigli Regionali, ma hanno, in perniciosa
aggiunta, innescato anche una situazione di disordine normativo dovuta al
conflitto di competenze fra questi tre livelli di capocrazia. La vicenda pandemica
ne è stata la testimonianza più significativa con la giungla di provvedimenti,
emessi da Governo, Regioni e Comuni (un quadro che rischia di essere ulteriormente aggravato dall’ipotesi
di “autonomia differenziata” messa in campo,
a giudizio di molti, come compensazione a quella del Premierato finalizzata al
mantenimento di equilibri interni all’attuale governo). Si è in questo modo, dando formale riconoscimento all’accentramento
dei poteri nella figura del Capo di
turno, creato un sistema diffuso di poteri “presidenzialisti” che giustifica
ampiamente il ricorso alla parola “capocrazia”. Va inoltre evidenziato che la
figura del Premier/Primo Ministro ha già conosciuto in questi stessi decenni, ben
prima di ogni proposta di riforma presidenzialista, un rafforzamento di poteri
tale da giustificare la constatazione di un “presidenzialismo di fatto”. Si è
trattato di un processo, avvenuto con il sempre più accentuato ricorso a Decreti Legge,
a Decreti
Delegati, a DPCM (Decreto Presidente Consiglio Ministri, diventati famosi proprio
durante la pandemia), il cui
utilizzo l’attuale Costituzione prevede limitato a casi eccezionali ed urgenti.
Di fatto il Parlamento si è in questo modo svuotato del suo potere legislativo
riducendosi a semplice organo confermativo visto anche il sempre più frequente
ricorso al “voto
di fiducia” (il Governo lo richiede per far approvare un Decreto, la cui
mancata approvazione lo farebbe automaticamente decadere). Si è giunti in questo modo ad un sostanziale svuotamento
dell’indicazione costituzionale che, a tutt’oggi, prescrive e norma una forma
di “governo parlamentare”. Il
percorso di approvazione della riforma costituzionale che mira all’introduzione
del premierato potrebbe allora rappresentare, positivamente, l’occasione per
riflettere su quanto è già avvenuto in modo strisciante e, valutando le
concrete ricadute già provocate dalla “capocrazia”
che si è così realizzata, meglio indirizzarla verso una scelta ragionata
……un mutamento tacito che si è consumato goccia a goccia, senza
revisioni formali del documento costituzionale, con una lente azione corrosiva
di comportamenti illegittimi legittimati dall’uso ripetuto …. il Presidenzialismo
di fatto subentrato alla centralità del Parlamento ne è la prova più evidente,
anche se non l’unica …… e forse è già troppo tardi per metterci rimedio ……
dopotutto il vero argomento che sostiene la riforma è proprio questo:
l’esigenza di riallineare la Costituzione scritta a quella materiale, al modo
in cui viene oggi applicata …..