Il “Saggio” del mese
DICEMBRE 2020
Prosegue con la sintesi della Parte Terza la
nostra pubblicazione come “Saggio” del mese, in questo caso di più mesi, della
monumentale opera di Thomas Piketty “Capitale ed
Ideologia”. Dopo aver esaminato nella Parte Prima la
forma delle disuguaglianze nelle società basate su tre ordini sociali,
nobiltà-clero-lavoratori, e l’ideologia che le sosteneva, e nella successiva Parte Seconda il loro superamento, nel corso del XIX secolo,
con l’affermarsi della “società dei proprietari”, espressione della
sacralizzazione ideologica del “diritto alla proprietà”, in questa Parte Terza Piketty analizza
quanto avvenuto nel corso del XX secolo, definito quello della “grande
trasformazione”. Si completa così il percorso storico delle forme di
disuguaglianze che hanno costruito, con il loro progressivo succedersi e con le
profonde eredità comunque lasciate, l’attuale struttura delle disuguaglianze e
della ideologia alla loro base, ossia la realtà di questo inizio del XXI secolo
nel quale siamo chiamati a ideare e realizzare una nuova “giustizia sociale”.
Ci scusiamo per la lunghezza di questa sintesi, ma non è stato possibile più di
tanto riassumere non tanto le parti di commento ed analisi quanto la notevole
mole di dati, raccolti in tabelle e grafici, che sostengono le valutazioni di Piketty (P.).
Per orientare la vostra lettura, se eventualmente interessata a parti
specifiche, il piano dell’opera di questa Parte Terza è
il seguente:
![]() Capitolo
10 =
dedicato alla crisi della “società dei proprietari” avvenuta nella prima parte del
secolo sulla spinta dei grandi mutamenti politici prodotti dai movimenti di
lotta popolari e dalla tragedia dei due conflitti mondiali
Capitolo
10 =
dedicato alla crisi della “società dei proprietari” avvenuta nella prima parte del
secolo sulla spinta dei grandi mutamenti politici prodotti dai movimenti di
lotta popolari e dalla tragedia dei due conflitti mondiali
![]() Capitolo
11 =
in cui si esaminano le società “socialdemocratiche”, intese in
senso molto lato, la loro concreta incidenza sulle disuguaglianze ed i loro
limiti e incompiutezze
Capitolo
11 =
in cui si esaminano le società “socialdemocratiche”, intese in
senso molto lato, la loro concreta incidenza sulle disuguaglianze ed i loro
limiti e incompiutezze
![]() Capitolo
12 = verte
sull’analisi delle cause che hanno prodotto l’indiscutibile fallimento delle
“società comuniste”, e delle evidenti contraddizioni presenti in quelle “post
comuniste”, con una attenzione particolare all’attuale Russia e alla anomalia
della Cina.
Capitolo
12 = verte
sull’analisi delle cause che hanno prodotto l’indiscutibile fallimento delle
“società comuniste”, e delle evidenti contraddizioni presenti in quelle “post
comuniste”, con una attenzione particolare all’attuale Russia e alla anomalia
della Cina.
![]() Capitolo
13 = chiude
il percorso esaminando le caratteristiche delle “società ipercapitaliste” della
attuale globalizzazione economica e ideologica a trazione neoliberista,
delineando il quadro finale sul quale interverrà la Parte Quarta.
Capitolo
13 = chiude
il percorso esaminando le caratteristiche delle “società ipercapitaliste” della
attuale globalizzazione economica e ideologica a trazione neoliberista,
delineando il quadro finale sul quale interverrà la Parte Quarta.
Va da sé che la lettura completa consente di meglio cogliere le
relazioni fra i vari Capitoli.
Parte terza
La grande trasformazione del XX secolo
Capitolo 10
La crisi della società dei
proprietari
(In cui P. completata l’analisi
delle precedenti forme di società ed individuate le loro possibili influenze
sulla struttura contemporanea delle disuguaglianze prende in esame la sua
evoluzione nel secolo dei grandi cambiamenti imposti dall’affermarsi totale del
capitalismo maturo
Ripensare la
grande trasformazione del XX secolo
Tra il 1914
ed il 1945 la struttura delle disuguaglianze globali conosce la trasformazione
più rapida e più profonda mai avvenuta nella storia, sancendo la crisi
definitiva delle società proprietaristiche esaminate nella Parte Prima. Sono
tre i principali fattori che innescano questa crisi:
![]() la gestione delle disuguaglianze interne, messe in discussione da
movimenti popolari ispirati da ideologie alternative
la gestione delle disuguaglianze interne, messe in discussione da
movimenti popolari ispirati da ideologie alternative
![]() la gestione delle disuguaglianze esterne, sottoposte alla
contestazione dell’ordine coloniale
la gestione delle disuguaglianze esterne, sottoposte alla
contestazione dell’ordine coloniale
![]() le sfide nazionalistiche ed identitarie che radicalizzano, fino al
conflitto aperto, i contrasti tra Stati
le sfide nazionalistiche ed identitarie che radicalizzano, fino al
conflitto aperto, i contrasti tra Stati
Per
comprenderli è utile una panoramica dei processi concretamente avvenuti in
questo periodo per quanto concerne l’evoluzione dei livelli di
disuguaglianza. Un
primo grafico illustra visivamente l’evoluzione della disuguaglianza di reddito
nelle due aree maggiormente caratterizzate dalla società proprietaristica del
XIX secolo, Europa ed USA
Grafico 34
Le due curve
segnalano processi sostanzialmente simili, con una progressiva contrazione
della ricchezza da reddito posseduta dal decile superiore fino al 1980 seguita
poi da una significativa ripresa verso l’alto. Ad uno sguardo più attento
emergono alcune rilevanti differenze: la curva europea, partita da livelli più
alti di quelli americani, conosce una discesa decisamente più accentuata e una
successiva risalita più moderata, al contrario quella statunitense presenta una
discesa più contenuta seguita da una più accentuata ripresa, tale da quasi
raggiungere le percentuali europee di inizio secolo. La situazione europea può
essere meglio compresa valutando il singolo comportamento dei paesi che di più
incidono nel determinare il dato medio
europeo, il seguente grafico aggiunge alle due curve di
quello precedente quelle specifiche di Regno Unito, Francia, Germania, e Svezia
Grafico 35
Il dato
europeo medio appare influenzato da due distinti percorsi: quello di Germania e
Regno Unito, che vede, salvo limitati picchi temporanei, una maggiore
percentuale di ricchezza rimasta in capo al decile superiore, al traguardo del
2010 il Regno Unito raggiunge infatti percentuali vicine a quelle statunitense,
con la Germania appena sotto, e quello di Francia e della Svezia, che si
assestano a livelli inferiori alla media europea. Per meglio comprendere questi
percorsi storici è opportuno, vista la sua incidenza sulla curva del reddito, evidenziare anche quella della
ricchezza patrimoniale, il dato che, all’alba del XX secolo, ben più del
reddito rappresentava il segno distintivo della società dei proprietari, in
particolare in Europa. Il seguente grafico analizza
l’evoluzione della quota percentuale di patrimonio privato posseduto dal decile
superiore, nel periodo 1900–2010, in Europa, USA, ed in tre significative
situazioni nazionali europee: Regno Unito, Francia e Svezia
Grafico 36
Emerge con
chiarezza come l’iniziale concentrazione di ricchezza patrimoniale sia stata,
soprattutto per l’Europa, decisamente più alta di quella del reddito (vedi grafico 35); raggiungendo agli inizi del secolo
percentuali mediamente comprese fra l’85% ed il 90%, mentre leggermente più
bassa, attorno all’80%, era quella americana. Nel corso del secolo questa
situazione patrimoniale si è capovolta: la comune discesa delle curve si è
infatti differenziata: la ricchezza patrimoniale del decile superiore statunitense
flette molto meno, per poi ritornare, nel 2010, a livelli molto vicini a quelli
di inizio 900, per contro il percorso europeo, omogeneo per i tre paesi in
esame, è caratterizzato da una discesa progressiva e costante e da una
successiva risalita molto più contenuta rispetto a quella americana
La fine delle
società proprietaristiche. Analisi del collasso dei patrimoni privati
(1914-1950)
Al di là
delle pur rilevanti differenze il dato fondamentale che emerge è comunque una
significativa contrazione delle percentuali di ricchezza, da reddito e
patrimoniale, possedute dal decile superiore in Europa. Per la prima volta
nella storia cambiamenti di fondo nella struttura delle disuguaglianze
attestano una qualche redistribuzione verso il basso. Un cambiamento simile non
può non evidenziare una trasformazione di fondo della idea stessa di
“proprietà” e del suo significato sociale. Per comprenderla è però necessario
per P.
collocare questo percorso in quello più generale del peso della ricchezza
privata sul reddito nazionale complessivo. Il seguente
grafico evidenzia l’incidenza del valore totale dei patrimoni privati,
posseduti dall’insieme della popolazione, sul totale del reddito nazionale nei
tre paesi europei economicamente più rilevanti:
Grafico 37
La
similitudine, visivamente evidente, con l’andamento delle curve dei precedenti grafici 35-36, è tale da rendere plausibile la
constatazione che la contrazione della ricchezza privata complessiva sia stata
determinata proprio dalla corrispondente perdita di ricchezza del decile più
ricco. Il grafico 37 evidenzia, anche in questo
caso, un trend comune per i tre paesi in esame, con una forte discesa nel
periodo 1910–1920, una relativa stabilità sul basso fra il 1930–1940, una nuova
discesa nel 1940–1950, una lenta ripresa fra il 1960 ed il 1990, seguita da un
più deciso salto verso l’alto dal 1990 al 2010. E’ quindi il periodo
1910/1914-1950 quello che di più spiega la caduta del peso della ricchezza
privata. I valori che questa aveva raggiunto al culmine della parabola storica
delle società proprietaristiche, arrivando a valere ben sette annualità di
reddito nazionale complessivo, scendono nell’arco di soli quattro decenni alla
metà nel Regno Unito e ad un solo terzo in Francia e Germania. Questo storico crollo
è dovuto ad un cumulo di fattori, fra i quali, contrariamente ad una opinione
diffusa, non più di tanto vale l’incidenza diretta dei due conflitti, vale a
dire che la distruzione materiale di case, edifici, fabbriche, e proprietà
varie, per quanto significativa, non è nel suo complesso così determinante. I
due tragici conflitti risultano invece
fondamentali per aver contribuito ad innescare, ovvero ad accelerare,
alcuni radicali cambiamenti in campo economico, sociale, politico, e quindi
ideologico.
Espropri,
nazionalizzazioni, sanzioni
Un primo
ordine dei fattori, innescati anche dall’eredità bellica e determinanti per il
crollo della ricchezza privata nel periodo 1914-1950, consiste nel rilevante
fenomeno degli “espropri”, vere e proprie pubbliche requisizioni di ricchezze
private. Il più clamoroso dei quali è stato sicuramente quello attuato dallo
Stato sovietico, immediatamente dopo la sua rivoluzionaria nascita, con la
cancellazione totale di tutti i titoli di debito pubblico del precedente Stato
zarista detenuti da investitori stranieri, in gran misura francesi ed inglesi.
Un esproprio dalle proporzioni gigantesche che ha comportato in molti casi il
totale azzeramento di numerosi patrimoni finanziari privati. Una situazione analoga si è poi verificata,
con disastri finanziari privati non meno rilevanti, nei primi anni 50 con
l’altrettanto clamorosa nazionalizzazione del Canale di Suez ed il collegato
esproprio di tutte le quote azionarie, anche in questo caso soprattutto in mani
francesi ed inglesi, deciso dal neonato governo rivoluzionario di Nasser. Un
episodio che inoltre ha simbolicamente testimoniato anche la fine della forma
classica dello sfruttamento colonialistico. E’ importante evidenziare che la lunga
catena di espropri, grandi e piccoli, del periodo 1914-1950, accanto
all’impressionante incidenza sulle ricchezze private di buona parte dell’Europa
attesta, congiuntamente con gli altri fattori che verranno qui di seguito
analizzati, una svolta ideologica fondamentale: la sacralità del “diritto di
proprietà” viene apertamente messa in discussione e svuotata della sua assoluta
inviolabilità. L’insieme delle formidabili lotte sociali e politiche mosse da
ideologie anti-proprietaristiche e dei provvedimenti, di fortissimo impatto,
resi indispensabili dal disastro finanziario provocato dai due conflitti, tale
in molti casi da mettere in discussione per molti paesi la stessa sopravvivenza
dello Stato, fa aggio sulla precedente convinzione che la ricchezza privata
dovesse godere di una inattaccabile protezione ideologica. E’ questa la svolta,
fatta propria da governi e partiti di opposto segno politico, con alcuni più
convinti ed altri obtorto collo, che P. giudica essere ispiratrice dei
processi che sanciscono la fine della “società dei proprietari”, incidendo
soprattutto sulle grandi ricchezze patrimoniali eredità di lungo termine della
stessa società ternaria. Nella stessa direzione, e con identiche motivazioni,
si muovono anche le ondate di nazionalizzazioni in diversi strategici settori
economici e produttivi, analoghi veri e propri espropri di ricchezza in mani
private, con la rilevante differenza che in questo caso sono state colpite
soprattutto le fonti della ricchezza imprenditoriale e capitalistica. Questi
processi di nazionalizzazione, attuati in alcuni casi per esigenze di natura
bellica ovvero per fronteggiare i disastri delle crisi economiche e produttive
degli anni Venti e Trenta, sono in aggiunta la significativa testimonianza
dell’affermarsi di una nuova concezione ideologica dello Stato, e del suo
diritto/dovere di interventismo diretto in economia. Una ulteriore importante
conseguenza dei processi di nazionalizzazione e dell’interventismo statale in
economia consiste infatti nella conseguente nascita di un “settore pubblico” di
grande consistenza che ha caratterizzato, dirigendole in buona misura e
rafforzandole per alcuni decenni ancora dopo il 1950, le economie di molti
Stati europei. La delegittimizzazione ideologica della sacralità della
proprietà privata sancita da espropri e nazionalizzazioni ha poi avuto
significative estensioni nell’adozione di rigide regolamentazioni dei mercati
finanziari, con l’adozione di pesanti sanzioni per le manovre speculative, di
leggi normative del mercato degli affitti immobiliari finalizzate a contenerne
i loro rendimenti e nel varo di diverse importanti riforme agrarie mirate a
frazionare le grandi proprietà terriere. Risparmio
privato, debito pubblico, inflazione
Un secondo
ordine di fattori che ha giocato in ruolo importante nel processo di contrazione
della ricchezza privata consiste nel mutato rapporto tra risparmio privato e
debito pubblico. La società dei proprietari, lungo tutto l’asse della sua
esistenza, si era monetariamente basata su due fondamentali capisaldi:
stabilità monetaria, garantita da una immutata convertibilità in oro, e assenza
pressochè totale di inflazione La Prima guerra mondiale, con la collegata
esplosione dei debiti pubblici, mette fine a questo trend storico di totale
stabilità aprendo la strada agli spaventosi fenomeni inflazionistici degli anni
Venti. Il successivo secondo conflitto mondiale accentua poi a dismisura il
peso dei debiti pubblici fino a divenire il volano per la definitiva inversione
del loro rapporto con il risparmio privato. I due
seguenti grafici aiutano a comprendere visivamente questi due processi: il
primo evidenzia per i tre più importanti paesi europei e per gli Stati Uniti la
curva del debito pubblico, nel periodo 1850-2020, calcolato in relazione
percentuale con il loro reddito nazionale, il secondo quella dell’inflazione,
come indice dei prezzi al consumo, sempre per lo stesso periodo:
Grafico 38
Si coglie
bene la inziale sostanziale assenza di debito pubblico che per tutti i paesi in
esame alla vigilia della Prima Guerra vale meno di un annualità di reddito
nazionale e il successivo considerevole balzo in alto avvenuto negli anni
1920-1950, seguito fino al 1970 da una significativa contrazione e da una
successiva ripresa verso l’alto
Grafico 39
Anche in
questo caso impressiona la totale assenza fino al 1914 di fenomeni
inflazionistici per tutti i paesi in questione. La Prima Guerra segna una
radicale inversione: l’inflazione cresce per tutti ma con comportamenti
differenziati che si possono comprendere solo se collegati alla corrispondente
evoluzione del debito pubblico del grafico 38 .
Mentre gli USA presentano, per ambedue le situazioni, curve meno accentuate,
quella del debito pubblico scende molto
più rapidamente per i paesi, come la Francia e la Germania, che di più hanno
fatto ricorso ad un alto tasso di inflazione, con una curva che quindi schizza
di molto verso l’alto, al contrario nel Regno Unito la curva cala molto meno,
ed ha una più lunga durata, proprio in
relazione ad un suo minor ricorso allo strumento inflattivo testimoniato da una
curva quasi costante fino al 1970. Il dato più importante da cogliere secondo P.,
al di là delle singole parabole, consiste da una parte nella conseguente
ricaduta sulla consistenza della ricchezza privata, intaccata dal processo
inflattivo, dall’altra, sul versante più ideologico, nel fatto che la scelta di
non più perseguire ad ogni costo la stabilità monetaria è spiegabile, anche in
questo caso, con l’abbandono della “sacralità” della proprietà privata. Per
meglio comprendere il primo aspetto, ossia la precisa scelta politica,
ricorrendo all’inflazione, di de-valorizzare i debiti pubblici in mani private
accumulati per sostenere i costi delle due guerre, si devono considerare i
corrispondenti notevoli prelievi forzati sui patrimoni privati attuati sia nel
primo sia nel secondo dopoguerra. Questi prelievi, molto rilevanti in Francia
ed in Germania, soprattutto negli anni 1945-1950, hanno persino avuto una
migliore efficacia per la contrazione del debito pubblico rispetto
all’inflazione, essendo sicuramente di più e meglio mirati a quote elevate di
ricchezza, ed, aspetto ideologicamente non meno innovativo, hanno aperto una
radicale svolta nel rapporto tra ricchezza privata e debito pubblico, con
quest’ultimo che fa aggio sulla prima. Su questa radicale inversione ideologica
si innesta una corrispondente nuova visione dell’insieme delle politiche
fiscali statali
Il ruolo
della tassazione progressiva e l’affermazione dello Stato sociale e fiscale
L’effetto dei
fattori esaminati è stato quindi quello di incidere pesantemente sul peso
percentuale della ricchezza privata su quella generale, così come rilevabile
dai grafici 34-35-36 i quali mostrano chiaramente
che la contrazione di quest’ultima è spiegata soprattutto con quella che ha
riguardato il decile più ricco, e che quindi negli anni 1914-1950 il processo
di contrazione della ricchezza privata globale si è accompagnato con quello
della sua concentrazione. Questo processo, unico nella storia delle
disuguaglianze, di contrazione della ricchezza privata globale abbinato a
quello della sua concentrazione trova, una sua ulteriore spiegazione nel
contemporaneo affermarsi di sistemi fiscali basati su un prelievo progressivo,
applicando cioè aliquote crescenti in rapporto al crescere del reddito. I seguenti grafici consentono di visualizzare questi
processi: il primo evidenzia, nel periodo 1900-2010, la curva del tasso
superiore di prelievo fiscale sul reddito in cinque paesi significativamente
rilevanti, il secondo la corrispondente curva della aliquota massima sulle
successioni sempre per gli stessi paesi
Grafico 40
Grafico 41
I due grafici
evidenziano situazioni differenti: il Grafico 40,
quello del tasso superiore di prelievo fiscale sul reddito, mostra un trend
sostanzialmente omogeneo delle curve, ma con una importante diversità nei
picchi raggiunti, il Grafico 41 presenta invece
comportamenti già del loro dissimili non riconducibili ad una tendenza
omogenea. Il grafico 40, più del grafico 41 presenta inoltre una corrispondenza
dell’andamento delle curve, seppure con trend rovesciato, con quelle dei
precedenti grafici 34–35–36, a testimonianza di
un più evidente comune atteggiamento nei confronti della ricchezza privata.
L’idea di una fiscalità progressiva, abbozzata nell’ultima parte del XIX secolo
solo in alcuni limitate situazioni, era del tutto incompatibile che l’allora
imperante ideologia proprietaristica, non a caso quindi si è potuta affermare solo
nel corso del XX secolo sulla decisiva spinta delle sue tragedie belliche. E'
soprattutto nei paesi “anglosassoni”, Regno Unito e Stati Uniti, che la svolta
assume caratteri dirompenti: già negli anni venti le loro aliquote fiscali sul
reddito arrivano a toccare il 60-70%, mentre negli altri paesi rimangono
mediamente attorno al 40%, per poi raggiungere nel secondo dopo guerra
aliquote, oggi inimmaginabili, dell’80-90% La sola Germania ha raggiunto tali
percentuali ma solo per un breve periodo dopo il 1945 quando, era sotto tutela
della Commissione alleata di controllo a guida americana. Questa significativa
diversità trova spiegazione, per il Regno Unito, nella crisi definitiva della
Camera dei Lord, baluardo così ottusamente ostinato nella difesa delle classi
alte da innescare una reazione opposta e contraria, e per gli Stati Uniti nella
considerazione che una disuguaglianza economica troppo alta fosse contraria
agli ideali originari dei pionieri. Non a caso la loro svolta verso la
progressività fiscale ha conosciuto alcuni primi passi già nel primo decennio
del XX secolo, per essere poi più compiutamente messa in atto nel Regno Unito
dopo lo shock finanziario della Prima Guerra e negli USA dopo le profonde
tensioni sociali della grande crisi degli anni Venti. Se il Giappone registra
una accelerazione solo nel secondo dopoguerra per sostenere una impressionante
ricostruzione post bellica, Francia e Germania adottano un progressività
fiscale meno accentuata con buona probabilità in relazione al fatto che i loro
grandi patrimoni privati erano già notevolmente colpiti dall’insieme dai
fattori esaminati in precedenza. E’ comunque comune per tutti questi paesi
“ricchi” l’avvento di una ideologia anti-proprietaristica alla base sia
dell’obiettivo di calibrare il contributo fiscale sull’effettiva ricchezza
guadagnata e sia su quello di ridurre l’incidenza di quella ereditata. Ambedue
questi obiettivi possono essere compresi, al di là delle parziali diversità di
applicazione, solo se inseriti nell’affermarsi di una più generale idea del
ruolo dello Stato nella gestione dell’economia e della giustizia sociale, un
risultato sicuramente frutto dei possenti movimenti popolari di lotta che per
tutto il periodo in esame accompagnano contrastandolo il progressivo affermarsi
del capitalismo
L’affermazione
dello Stato sociale e fiscale
L’accertata
incidenza della fiscalità progressiva sul processo di contrazione delle
disuguaglianze nel periodo 1914-1950 si inserisce, proprio grazie a queste
lotte, in quello più generale di una progressiva maggiore fiscalità dello Stato
finalizzata ad accrescere il suo ruolo nella gestione, via via più ampiata, dei
servizi sociali. Aiutano a visualizzare il trend di questi processi il seguente grafico 42 che illustra la curva di crescita percentuale
delle entrate fiscali sul reddito nazionale per cinque significativi paesi nel
periodo 1900-2010, ed il successivo grafico 43 che ripartisce queste entrate
fiscali, sempre in percentuale sul reddito nazionale, per le voci che
compongono l’idea di “Stato sociale” in Europa nello stesso periodo
Grafico 42
Ancora agli
inizi del XX secolo le entrate fiscali di tutti gli Stati non superavano il 10%
del reddito nazionale, in linea con la percentuale degli ultimi decenni del XIX
secolo nel pieno della società proprietaristica. Inizia dal 1910 una
progressione a salire sostanzialmente omogenea fino al 1950 assestandosi
mediamente attorno al 40%, con ai due estremi gli USA fermi al 30% e la
Svezia ad un livello superiore al 50%. Questo trend dei livelli percentuali di
fiscalità va relazionato a due importanti evidenze:
![]() tutti i paesi
presi in esame hanno conosciuto la loro fase di maggior sviluppo economico in
presenza di una consistente percentuale di prelievo fiscale, compresa in una
fascia che va da un minimo del 30% ad un massimo del 55%
tutti i paesi
presi in esame hanno conosciuto la loro fase di maggior sviluppo economico in
presenza di una consistente percentuale di prelievo fiscale, compresa in una
fascia che va da un minimo del 30% ad un massimo del 55%
![]() la maggior
disponibilità di risorse fiscali si è dimostrata essenziale per sostenere il decisivo ruolo del pubblico
per lo sviluppo economico e per l’equilibrio sociale
la maggior
disponibilità di risorse fiscali si è dimostrata essenziale per sostenere il decisivo ruolo del pubblico
per lo sviluppo economico e per l’equilibrio sociale
La
ripartizione della spesa resa possibile da questi livelli di risorse fiscali
testimonia la seconda evidenza
Grafico 43
Il percorso
illustrato dal grafico si presenta lineare, non essendo stati presi in
considerazione gli scarti, in aumento o in diminuzione, di breve periodo, ed
evidenzia quindi una crescita costante e significativa. Si è passati da una
situazione di inizio secolo in cui le spese statali, pari al 10% del reddito,
potevano coprire solo le attività statali “classiche” - esercito, polizia,
giustizia, amministrazione centrale e locale, gestione infrastrutture – e solo
in minima parte l’istruzione, al tempo ancora non di massa. Il risultato finale
a fine secolo, oggetto oggi di un cruciale dibattito sulla sua validità e
sostenibilità, attesta invece l’ampia gamma di servizi sociali coperti dallo
“Stato fiscale” che conosce, soprattutto nella seconda metà del secolo, un suo
importante incremento. Questa evoluzione è stata possibile solo per il radicale
mutamento dei rapporti di forza politico-ideologici avvenuto nel periodo
1910-1950, frutto del lungo e intenso ciclo di lotte sociali, sindacali,
politiche che, come si è già evidenziato, è alla base della crisi della società
dei proprietari e del collegato crollo della ricchezza privata. Un’ultima
specifica osservazione sulla struttura dello “Stato fiscale”, che P. ritiene
rilevante e sulla quale tornerà quindi nelle Parti conclusive del saggio: il
complesso dei servizi coperti dallo Stato sociale in Europa vale mediamente il
47% del reddito nazionale, i sistemi fiscali diffusi nel vecchio continente
necessari a coprire il correlato fabbisogno fiscale non puntano ad un unico
prelievo percentuale ma si sono via via articolati in una miriade di tasse,
imposte e contributi a formare un insieme così complesso ed opaco da offrire
così spazio ad opposizioni e resistenze spesso di natura populista
Il ruolo
delle lotte sociali e ideologiche
Come già più
volte evidenziato è’ dato storico acquisito il decisivo peso dei movimenti di
lotta in tutti i processi di trasformazione sociale del secolo XX. P. si
limita quindi in questo saggio a evidenziare un loro decisivo aspetto:
l’opposizione al duro sfruttamento
capitalistico, ispirata e indirizzata dalle elaborazioni teorico-politiche di
ispirazione socialista e comunista, individuano da subito nella sacralizzazione
ideologica della “proprietà” il nemico principale da battere, diventando così il
fattore principale nel determinare il suo significativo ridimensionamento sin
qui esaminato. Alcuni aspetti specifici sono, a suo avviso, utili a meglio
definire l’intreccio con i processi reali che hanno inciso sulla struttura
delle disuguaglianze. Un primo aspetto consiste nel duplice effetto da esse
provocato: da una parte sono evidenti i concreti risultati ottenuti nel
contrastare, migliorando le condizioni di lavoro e di vita, l’accumulazione di
ricchezza, dall’altra non meno importante è stato l’aver indotto altrettanto
decisivi cambiamenti nelle politiche governative in materia di fiscalità e di
gestione sociale. La Rivoluzione bolscevica del 1917, e la successiva presenza
del blocco sovietico nel secondo dopoguerra, con il timore della loro
diffusione, hanno fortemente accelerato ed ampliato molti dei processi, in
precedenza esaminati, che hanno determinato la riduzione della ricchezza
privata e la contrazione della quota in capo al decile superiore. Un esempio
fra i tanti: la diffusa paura di una espropriazione generalizzata ha reso la
tassazione progressiva una concessione alternativa molto meno spaventosa. La
storia peraltro dimostra che non tutte le reazioni a questo timore abbiano
segnato ricadute positive. Senza chiamare in causa la nascita delle dittature
fasciste e nazista, in gran misura sorte proprie per contrastare le forti lotte
popolari del primo dopoguerra, è bene ricordare che nel 1938 si tenne a Parigi
un convegno di economisti ed intellettuali vari che si riproponevano, per
fronteggiare la crescente richiesta di pianificazione economica e di
collettivismo, di rilanciare una visione della società in linea con lo spirito
capitalistico delle origini, una rinascita in quella circostanza già
ufficialmente denominata “neo liberismo”. Alcuni decenni dopo uno dei più
importanti partecipanti, l’economista tedesco Friedrich Hayek diventerà un
punto di riferimento per Margaret Thatcher e le sue politiche di smantellamento
dello Stato sociale, e addirittura uno stretto collaboratore di Augusto
Pinochet. In questi stessi anni il nome “neoliberismo” acquisterà la diffusione
planetaria che ben conosciamo. P.
ritiene inoltre che vada in qualche misura ridimensionato il peso della Prima
Guerra sullo sviluppo delle lotte popolari. La stessa Rivoluzione bolscevica è
stata sicuramente agevolata dalle tensioni interne prodotte dal conflitto, ma è
altrettanto evidente che la disgregazione del regime zarista era già del suo in
uno stadio avanzato ed irreversibile. Alcuni importanti movimenti di lotta non
hanno neppure avuto un diretto collegamento con il conflitto mondiale del 1914.
Così è stato per il movimento sindacale americano il cui incubatore è
rappresentato dalla “Grande Depressione” del 1929-1933, magnificamente
raccontata da Steinbeck nel suo romanzo “Furore” del 1939. Ma così è stato
soprattutto per la Svezia, che non partecipa alla prima Guerra e che vede la
sua parabola socialdemocratica realizzarsi come compimento di un lungo percorso
di lotte popolari iniziate già nell’ultimo decennio del XIX secolo.
Capitolo 11
Le società socialdemocratiche:
l’uguaglianza incompiuta
(In cui P. inizia ad analizzare le
alternative effettivamente concretizzatesi alla società dei proprietari e la
loro reale capacità di realizzare una forma di società con una struttura delle
disuguaglianze coerente con i loro presupposti ideologici. Iniziando in questo
Capitolo 11 con le società socialdemocratiche per poi passare, nel successivo
Capitolo 12, a quelle comuniste e post comuniste
Le società
socialdemocratiche europee
Nel Capitolo
precedente si è individuato nelle lotte popolari di opposizione al capitalismo
e il protagonista fondamentale del cambiamento intervenuto nella struttura
delle disuguaglianze nel corso del XX secolo nei paesi occidentali. Le fonti di
ispirazione ideologica di tali lotte, e dei possenti movimenti sindacali e
partiti che le ha attuate, possono essere divise, a grandi linee, in due
filoni, fra di loro molto spesso intrecciati ma ancora più spesso in aperto
contrasto: pensiero socialista e socialdemocratico, e pensiero comunista.
All’indomani del secondo conflitto la scena politica mondiale si presenta divisa
in due blocchi geograficamente definiti seppure con notevole approssimazione e
qualche anomalia: quello occidentale, con economia di tipo capitalistico, e
quello orientale, con economia di tipo collettivistico. Non pochi paesi del
blocco occidentale sono tuttavia definibili “società socialdemocratiche” ovvero
società che, con varie combinazioni e gradualità, attuano politiche di gestione
dei sistemi pubblici di sanità, istruzione, welfare, politiche fiscali e di
indirizzo economico e sociale che in qualche modo puntano a governare il
“capitalismo” attutendone contraddizioni ed eccessi. Ciò avviene nell’ambito
delle democrazie rappresentative che
implicano alternanze di governi e politiche, ma è comunque possibile,
secondo P.,
sostenere che, per alcuni decenni dopo la Seconda Guerra, la struttura delle
disuguaglianze in molti paesi del blocco occidentale è stata in buona misura
impostata su una visione “socialdemocratica” della società, se in essa si
includono esperienze anche molto
dissimili fra di loro: alcune di chiara ispirazione socialista, altre come
quella statunitense lontane da tale ideologia ma in grado di attuare a più
riprese politiche molto simili a quelle socialdemocratiche, si pensi al New
Deal roosveltiano piuttosto che alla “war on poverty”, la “guerra alla povertà”
degli anni sessanta. Nel periodo 1950–1980 questo insieme, per quanto variegato
e disomogeneo, di politiche, secondo P. comunque
definibili in senso ampio “socialdemocratiche”, realizza il livello più basso
di disuguaglianze mai conosciuto nella storia. Dal 1980 si assiste però ad una
radicale inversione: la disuguaglianza torna a salire con rapidità e
consistenza, e la “socialdemocrazia”, ovvero tutte quelle definibili tali in
senso ampio, non appare più in grado di orientare la società come nel
trentennio precedente. Il seguente grafico evidenzia questo
ritorno della disuguaglianza mettendo a confronto la quota parte del reddito
annuale detenuta dal 10% più ricco e dal 50% più povero nel periodo 1980-2010 per
le aree economicamente più rilevanti: USA-Europa-Cina-India
Grafico 44
Appare evidente
la forte crescita del divario fra queste due parti della popolazione: il decile
superiore passa da una forbice compresa tra il 27% ed il 34% nel 1980 ad una
compresa tra il 34% dell’Europa ed il 52% dell’India nel 2010, negli stessi
anni il cinquanta per cento più povero passa da una forbice compresa tra il 20%
ed il 27% ad una compresa tra il 13% degli USA ed il 20% dell’Europa, la quale
risulta pertanto quella che registra la minore impennata delle disuguaglianze.
E’ quindi necessario interrogarsi sulla effettiva solidità delle realizzazioni
“socialdemocratiche” e sulle ragioni che hanno determinato questa inversione di
tendenza. P. lo fa analizzando quanto realizzato nei settori che di più
concorrono a determinare disuguaglianza, a partire dal “lavoro” e dal suo
rapporto con le forme di “proprietà”.
La “proprietà
sociale”, una storia incompiuta
In Europa,
nelle aree renane e nordiche, in particolare in Germania ed in Svezia,
l’influenza della ideologia socialdemocratica in questo campo è misurabile
soprattutto nell’istituto della “cogestione”, una forma istituzionalizzata di
proprietà sociale delle imprese e di condivisione di potere tra dipendenti ed
azionisti. Sull’onda della fortissima mobilitazione dei sindacati tedeschi, che
già negli anni venti della Repubblica di Weimar aveva fortemente puntato sui
diritti dei comitati aziendali, e superata la traumatica parentesi nazista, nel
1951 una legge, promulgata dal governo cristiano-democratico di Adenauer, a
conferma della influenza “trasversale” di molte idee socialdemocratiche,
sanciva per le grandi imprese dell’acciaio e del carbone l’obbligo di riservare
metà dei seggi e dei diritti di voto nei consigli di amministrazione a
rappresentanti dei dipendenti, di solito eletti in liste sindacali. Successivi
aggiustamenti hanno portato alla definitiva legge generale sulla cogestione del
1976 che, in linea con quanto sancito dalla Costituzione tedesca del 1949, là dove
afferma che il “diritto di proprietà” deve contribuire al benessere generale,
ha esteso a tutte le aziende con oltre duemila dipendenti l’obbligo di
riservare a rappresentanti dei lavoratori la metà dei seggi con diritto di
voto, mentre per quelle che contano tra cinquecento e duemila dipendenti la
quota è fissata in un terzo dei seggi. Non mancano limiti e problematiche, in
particolare non sempre la parità di seggi nei consigli di amministrazione
comporta un vero esercizio di potere, in caso di parità infatti il voto
decisivo è comunque quello degli amministratori scelti dagli azionisti, ed
inoltre gran parte delle decisioni operative è in capo ad un consiglio
direttivo che affianca, in autonomia, quello di amministrazione. La cogestione
tedesca è comunque considerata, dalle stesse proprietà azionarie, uno dei
fattori fondamentali per la crescita e la solidità dell’economia tedesca, ed al
tempo stesso è indubbio che essa abbia contribuito a contenere la
disuguaglianza salariale imponendo tetti alle retribuzioni del management
aziendale, al contrario esplose a partire dal 1980 nel resto dell’Occidente.
All’esperienza tedesca, che ha influenzato anche la vicina Austria, si affianca
quella svedese che, ancor più della Germania ed in modo più incisivo, ha fatto
della cogestione una bandiera della sua idea complessiva di società. In Svezia
infatti la legge del 1974 che la norma prevede che un terzo dei seggi dei
consigli di amministrazione delle imprese azionarie con più di soli venticinque
dipendenti sia riservato a rappresentanti dei dipendenti. Essendo poi in capo
ai CdA la vera gestione operativa la quota detenuta dai lavoratori incide in
misura maggiore rispetto a quella tedesca ed investe molte più aziende.
Analoghe leggi sono presenti in Danimarca e Norvegia a caratterizzare il
cosiddetto “capitalismo nordico”, vale a dire le società che vantano la minore
disuguaglianza economica di tutta la storia moderna. L’indubbia incisività di
queste esperienze sulla struttura delle disuguaglianze salariali, coniugata con
un eccellente ritorno sulla produttività economica, non è stata però
sufficiente per vederle estese ad altri paesi occidentali, i quali hanno tutti
continuato a gestire le aziende private secondo l’immutabile regola delle
società azionarie: “un’azione un voto”. Se qualche timido tentativo in tal
senso è stato avviato in Francia, e se nel Regno Unito e negli Usa si è con
molta cautela affacciata qualche ipotesi per ora senza esito alcuno, in
generale il modello della “cogestione” non è divenuto patrimonio delle altre
socialdemocrazie e dei movimenti e partiti che le sostengono. Due sembrano
essere le principali spiegazioni: una sta nel campo dei proprietari capitalisti
ed una in quello degli stessi rappresentanti dei lavoratori. La prima sostiene
che la concessione di una rappresentanza con diritto di voto non giustificata
da un reale possesso azionario vada respinta perché mette in discussione il
concetto stesso di “proprietà privata”, con il conseguente rischio di poter
rappresentare una operazione destabilizzante dell’intero ordine sociale. Se
teoricamente nulla osta a che i dipendenti, o chi per essi, acquisiscano quote
azionarie, così come è concretamente avvenuto seppure in casi limitati ed
ininfluenti, la gestione aziendale deve essere ispirata unicamente dalla regola
aurea che consegna agli azionisti di maggioranza il pieno potere decisionale.
La cogestione però non è neppure entrata nel bagaglio di idee della stragrande
maggioranza dei movimenti dei lavoratori che, seguendo un percorso ideologico
molto condizionato dall’esperienza sovietica, hanno da sempre puntato in
alternativa sulle “nazionalizzazioni”, sulla base della convinzione che solo
quella statale possa davvero modificare i rapporti di forza tra dipendenti e
proprietà. Discendono da questa concezione ideologica le forti critiche mosse
alla cogestione, in particolare quella del rischio di ridursi ad essere un
coinvolgimento nelle logiche aziendali che mina la combattività verso la
proprietà. Anche se dagli anni Ottanta, specie dopo la fine del collettivismo
sovietico ed indipendentemente dalla guerra neoliberista al ruolo del
“pubblico”, l’idea della “nazionalizzazione” ha perso gran parte del suo
vigore, le diversità storiche di percorso ideologico hanno sedimentato in tutti
gli altri paesi occidentali una insuperata diffidenza verso la “cogestione”.
L’accentuarsi dagli anni Ottanta delle curva delle disuguaglianze imporrebbe,
secondo P. di riprendere con rinnovato vigore politiche del lavoro in grado
di meglio fronteggiarla, anche riavviando una riflessione senza preconcetti
sulla efficacia di modelli, come la “cogestione”, che la storia dimostra di
essere in grado di incidere in qualche modo in tal senso. E’ quanto P.
farà nella Parte Quarta anche con riferimento ad alcune concrete proposte, mirate
proprio all’estensione della “proprietà sociale”, avviate dalla stessa Unione
Europea. Accanto alla cogestione va poi citata una seconda forma di gestione
alternativa del “lavoro”: la cooperazione. Nata e cresciuta nell’ambito dei
movimenti di lotta in tutta Europa fin dalla fine del XIX secolo, in
particolare nelle forme delle “società di mutuo soccorso” e delle “cooperative
sociali”, ha mantenuto a lungo anche nel secondo dopoguerra una sua valenza, ma
via via perdendo per strada la sua caratteristica iniziale di autogestione
alternativa di importanti attività lavorative e riducendosi ad una “normale”
forma societaria ormai priva di valenze ideologiche.
La
socialdemocrazia e l’istruzione
Ancora in
questo inizio del XXI secolo rappresenta una sfida, per le stesse società
socialdemocratiche, il garantire a tutti i cittadini pari opportunità di pieno
accesso all’istruzione, alla formazione e qualificazione professionale. P.
estrapola dall’esperienza globale concretamente avvenuta nel periodo storico in
esame due aspetti utili a suo avviso a meglio comprendere i limiti della
gestione socialdemocratica dell’istruzione: la fine del vantaggio statunitense
nel campo dell’istruzione mantenuto per la maggior parte del XX secolo, e
l’imporsi generalizzato della sfida del passaggio dal semplice “obbligo
scolastico” al paradigma di una istruzione “alta” accessibile a tutti. Per
comprenderli è utile analizzare la parallela evoluzione di un indicatore strettamente
collegato all’istruzione: la produttività del lavoro. Il
seguente grafico mette a confronto la produttività media del lavoro, misurata
in base alla quota di PIL prodotto in un’ora di lavoro a parità di potere
d’acquisto in euro, negli USA – Germania – Francia – Regno Unito nel periodo
1950 – 2010
Grafico 45
Si può
cogliere bene come la produttività media europea, partita da una situazione che
nel 1950 valeva il 50% di quella statunitense, sia poi progressivamente salita
di più di quella USA. Il livello medio di istruzione di un paese, oltre ad
essere un fondamentale valore morale e civile, ha una forte incidenza diretta
sulla produttività in particolare là dove intervengano continue innovazioni
tecnologiche, le quali richiedono, per rendere al meglio, personale formato in
modo adeguato. Il calo o l’aumento di produttività sono quindi, come logica
ricaduta, indicatori importanti del livello di istruzione di un paese e della
sua qualità. Quello statunitense è stato a lungo indubbiamente migliore di
quello europeo grazie al un consolidato percorso storico di maggiore
investimento sull’istruzione diffusa, attestato dai seguenti dati:
·
già a metà del secolo XIX l’80% dei bambini americani frequentava
e completava la scuola primaria, mentre in Europa mediamente non si andava
oltre il 20%-30%
·
nei primi decenni del 1900, mentre
l’Europa recuperava faticosamente tale gap, negli Stati Uniti si
consolidavano la diffusione di quella secondaria che già toccava il 30% dei
giovani fra i 12 ed i 17 anni
·
nel secondo dopoguerra negli USA si completava la realizzazione di
una istruzione secondaria universale, in questi stessi anni il corrispondente
tasso di iscrizione europeo si fermava mediamente al 30%
Questi dati
spiegano la storica migliore capacità degli USA di assecondare la costante
immissione di nuova tecnologia con una società generalmente più istruita e
quindi con una forza lavoro più attrezzata ad usarla in modo ottimale. A
partire dagli anni cinquanta, e con una forte accentuazione dal Settanta, si
assiste però ad una inversione di tendenza: da una parte le socialdemocrazie
europee di più e meglio individuano nell’istruzione un fattore decisivo per la
crescita sociale e produttiva, avviando estese politiche di investimento in
questo settore, dall’altra negli Stati Uniti si registra al contrario ad un
processo inverso. Queste traiettorie contrapposte sono meglio comprensibili se
in aggiunta alla curva di crescita della produttività si analizza quella della
ripartizione del reddito. Il seguente grafico evidenzia
la quota di reddito posseduta dal 50% più povero della popolazione negli Stati
Uniti ed in Europa, dato medio, nel periodo 1960 – 2010.
La situazione
al 1960 vede il 50% più povero negli Stati Uniti contare su una quota di
reddito nazionale significativamente superiore a quella posseduta dal corrispondente europeo, solo dieci anni dopo
però le due curve coincidono per poi dividersi con quella europea che ha un
balzo in alto fino al 1980 seguito da una contenuta discesa e quella
statunitense che inizia una costante discesa con un ritmo che si accentua a
cavallo del cambio di secolo,fino a
registrare una notevole diversità finale. Questo processo è importante per
comprendere le dinamiche legate al peso degli investimenti per l’istruzione in
quanto certifica che la scelta delle società socialdemocratiche di investire su
di essa è compensata non solo in termini di aumento della produttività media,
ma per il fatto di costituire, come logica conseguenza, un significativo volano
per la crescita del reddito medio dei ceti che, grazie al miglioramento della
loro istruzione, meglio possono concorrere nel mercato del lavoro puntando a
professionalità meglio retribuite. Un processo che al contrario negli Stati
Uniti si è esattamente invertito proprio a partire dagli anni
Cinquanta/Sessanta. Un altro grafico aiuta a
visualizzare questa significativa ricaduta evidenziando la curva di crescita
del salario minimo medio per ora di lavoro in Francia e negli USA nel periodo
in esame (rapportato in euro)
Grafico 47
Si tratta di
un dato ovviamente influenzato da diversi fattori, quali la contrattazione
sindacale e la legislazione in materia di lavoro, ma è, come il precedente grafico 46, in grado di fornire una indicazione utile
a comprendere la diversità di ricaduta delle due diverse traiettorie sulle
condizioni di vita dei salariati statunitensi e francesi, e che conferma quindi
la migliore qualità delle politiche per l’istruzione europee rispetto a quelle
statunitensi. La crescente incidenza della tecnologia sui processi produttivi
ha però progressivamente alzato l’asticella del livello di istruzione ed ha
così visto divenire decisivo quella di livello universitario, innescando nuove
domande che stanno mettendo a dura prova ambedue i sistemi. Se l’istruzione
universitaria aveva per molto tempo interessato solo una quota privilegiata,
meno dell’1% agli inizi del XX secolo e meno del 10% fino agli Sessanta, oggi
investe il 50% dei giovani adulti negli USA e in buona parte dell’Europa per
arrivare al 60-70% in Giappone e in Corea ed impone un ulteriore salto di
qualità nelle politiche di facilitazione al suo accesso. Il quadro da
considerare è quanto mai complesso, influenzato da fattori di diversa natura
che chiamano in causa non solo le possibilità di accesso ma anche la qualità
della formazione. Soprattutto negli USA
la formazione universitaria di alto livello comporta un “investimento” delle
famiglie tale da far emergere il peso delle diversità di reddito e l’importanza
del sostegno pubblico. Riprendiamo il seguente grafico,
già inserito nell’Introduzione, che offre un preciso spaccato del rapporto
reddito dei genitori e accesso all’università
Grafico 7
Appare
evidente il peso del reddito famigliare sulla possibilità di accesso
all’offerta formativa di qualità, negli USA, ma anche in Europa più questa
cresce più si restringe la fascia di popolazione che può utilizzarla. Incide
poi in modo rilevante la grande differenza fra Stato e Stato del peso del
finanziamento privato, rispetto a quello pubblico, per la formazione di livello
superiore. Il seguente grafico evidenzia la quota
percentuale del finanziamento privato (tasse di iscrizione e costi collegati di
frequenza) sul totale del finanziamento totale per l’offerta di istruzione
universitaria per una parte significativa dei paesi “ricchi” del mondo (dati
2014-2016)
Grafico 48
L’evidente
disparità fra i paesi di cultura “anglosassone”, in cui il finanziamento
privato è preponderante, e quelli europei di maggior tradizione
socialdemocratica è alla base di un circolo vizioso: maggiori sono i contributi
privati maggiore è la qualità dell’offerta formativa, ma al tempo stesso più
alti sono i costi per accedere a tale offerta e più è bassa la parte della
popolazione in grado di sostenerli. Con una evidente ricaduta sulla
disuguaglianza: il Grafico 7, combinato con il Grafico 48, attesta che solo la parte più ricca della
popolazione accede ai titoli di studio che garantiscono professioni con alti
livelli di reddito perpetuando, se non accentuando, in questo modo il divario
elitario. Mediamente la situazione europea garantisce al contrario maggiori
possibilità di accesso ma al tempo stesso, non godendo di identiche risorse,
non è in grado di concorrere con la qualità dell’offerta formativa dei paesi
“anglosassoni”. Un dato di fatto che è confermato dalle classifiche
internazionali di questa qualità: i primi venti posti sono tutti occupati dalle
università statunitensi di maggiore prestigio, ma se si considerano i primi
cento o cinquecento posti diventa maggiore il numero di quelle europee, le
quali quindi formano una élite universitaria più diffusa, anche se meno
concorrenziale, mentre quelle USA rafforzano unicamente quella di vertice
garantendole alta concorrenzialità. In conclusione si può quindi affermare che
il modello americano ha smesso di essere quello vincente, nel contrasto alla
disuguaglianza, sia per l’istruzione secondaria che per quella universitaria, mentre
il modello socialdemocratico europeo se ha ottenuto sul lungo periodo migliori
risultati per la prima dimostra una certa difficoltà a ottimizzare la seconda,
la cui sfida richiede un salto di qualità politico ed ideologico. Una sfida che
non sembra essere stata sufficientemente raccolta: la spesa pubblica per
l’istruzione, compresa quella universitaria, cresciuta nel corso del XX secolo
dall’iniziale 1-2% del reddito nazionale al 5-6% negli anni Ottanta si è poi
fermata a queste percentuali con una inevitabile ricaduta negativa sulla
qualità dell’offerta formativa, specie di livello superiore.
Socialdemocrazia
e giustizia fiscale: un incontro imperfetto
I limiti
evidenziati da P.
delle società socialdemocratiche nell’attuare più incisive politiche di
contrasto delle disuguaglianze nel campo del lavoro e dell’istruzione rimandano
ad una comune spiegazione: l’inadeguata disponibilità di risorse pubbliche per
fronteggiarle al meglio, fattore che a sua volta chiama in causa il tema della
giustizia fiscale. Ed anche in questo caso il concreto percorso storico
evidenzia una cesura fra il significativo sviluppo nel periodo 1914-1950 delle
forma di imposizione che di più può contrastare la disuguaglianza, quella
progressiva su reddito e successioni, e la successiva ritrosia ad adeguarlo
alle nuove sfide sociali, a dimostrazione di una inadeguata elaborazione
politica ed ideologica. Due punti meritano una attenzione particolare: in primo
luogo le varie socialdemocrazie non sono state in grado di elaborare comuni
strategie fiscali lasciando campo ad una penalizzante competitività fra singoli
paesi, ancor più grave quella avvenuta nell’ambito dell’Unione Europea, ed in
secondo luogo la progressività fiscale ha smesso di essere lo strumento
fondamentale per qualsiasi tentativo minimamente ambizioso di superamento del
capitalismo privato. Emerge, a spiegare questo stato di cose, una
contraddizione ideologica di vitale importanza: la socialdemocrazia del XX
secolo è stata “internazionalista” nei principi, ma fortemente “nazionalista”
nella pratica. Questa contraddizione ha avuto una pesante ricaduta sulla
capacità, e sulla stessa volontà, di articolare politiche fiscali più efficaci.
La stessa costruzione dell’unità europea nel periodo 1950-2000 si è di fatto
configurata, al di là degli intenti ideali, come una operazione di “salvataggio
della forma Stato nazione”, dei singoli Stati aderenti. La costruzione europea
si è infatti basata sull’illusione che la libera circolazione di merci e
capitali fosse sufficiente a garantire una ricaduta sociale positiva e che
quindi non fosse necessario supportarla con comuni politiche fiscali. Ciò ha
comportato gravi limiti per la reale capacità di incidere sulla struttura delle
disuguaglianze. Un fallimento divenuto poi clamorosamente evidente nella
cruciale svolta del 1980-1990, allorquando, nel momento in cui di più sarebbero
state utili comuni politiche fiscali, si è all’opposto puntato di fatto su una
accentuata concorrenza fiscale specie sugli utili aziendali. Va detto inoltre
che questa svolta negativa non può essere spiegata solo con la pressione
ideologica del nascente neo-liberismo perché è documentato il ruolo assunto, in
questa direzione, proprio dai principali partiti socialdemocratici europei,
mettendo ancor più in luce l’assurdità ideologica che le grandi sfide imposte
dalla globalizzazione neo-liberista fossero affrontabili singolarmente da ogni
“Stato nazione” europeo. Ed era già allora evidente che i primi settori che
avrebbero sofferto l’inadeguatezza di adeguate risorse finanziarie sarebbero
stati, congiuntamente con tutti quelli che configurano l’idea di “stato
sociale” europeo, proprio quelli che di più incidono sulla struttura delle
disuguaglianze: istruzione e lavoro. Non a caso n questo quadro ha poi avuto
gioco facile l’irruzione dirompente dell’ideologia neo-liberista di contrasto
al ruolo del pubblico e di rifiuto della tassazione necessaria a sostenerlo.
Una fotografia aiuta a comprendere come l’articolazione delle imposte si sia
conseguentemente strutturata a favore dei redditi più alti: un seguente grafico evidenzia, prendendo in esame il caso
francese nel 2010, del tutto applicabile alla media degli Stati europei, la
composizione del prelievo fiscale nelle sue varie voci relazionata alla
popolazione suddivisa per centili di reddito:
Grafico 49
Si può
rilevare come, a fronte di un prelievo fiscale totale pari al 45-50% per il 50%
più povero, del 50-55% per il 40% mediano, e solo del 45% del decile e centile
più ricchi, le quote di imposta progressiva e di tasse sul capitale di questi
ultimi non compensano il ridotto importo dovuto per le altre voci impositive.
Una fotografia che richiama prepotentemente in causa il ruolo della fiscalità
progressiva e della tassazione sulla proprietà concretamente attuato nelle
società “socialdemocratiche” subentrate, in teorica piena alternativa, a quella
proprietaristica. La progressività della tassazione è una scelta ideologica
finalizzata in generale al contenimento delle disuguaglianze economiche, ma a
seconda della tipologia di ricchezza sulla quale agisce ha incidenze diverse.
Quella sul reddito, da lavoro e da capitale, è il contributo, relazionato
all’ammontare del reddito, con cui tutti concorrono alla spesa pubblica, quella
sulle successioni incide sui patrimoni trasmissibili in via ereditaria
riducendo quindi la concentrazione dei patrimoni tramite la perpetuazione
intergenerazionale. Tutte hanno una loro efficacia sulla struttura delle
disuguaglianze, ma quella che di più ha una valenza in tal senso è senza dubbio
l’imposta annuale sulle proprietà, altrimenti definita sulla ricchezza, sul
capitale, sul patrimonio. La disuguaglianza economica ha un processo standard
di formazione che parte da una differenza di reddito prolungata nel tempo, ma
che si consolida divenendo stabile nell’accumulo di una ricchezza,
trasmissibile in via ereditaria, composta in gran prevalenza da beni immobili e
capitali finanziari di vario genere. Una attiva politica fiscale, che si ponga
l’obiettivo del contenimento della disuguaglianza, deve realizzare un
equilibrio tra queste tre forme di imposta progressiva, ben sapendo però che
quella che di più attesta la volontà egualitaria è sicuramente quella sulle
proprietà. Non a caso, proprio in relazione alla sua valenza ed alla
conseguente opposizione che può suscitare, è anche quella che di meno è stata
attuata nelle stesse società socialdemocratiche. La storia del XX secolo
racconta di imposte sul patrimonio attuate, con carattere di prelievo
straordinario, negli immediati dopoguerra al fine di ripianare gli altissimi
debiti pubblici. In diversi paesi, anche nella forma di “riforme agrarie”,
furono messi atto prelievi che sulle grandi ricchezze sono arrivate a
percentuali attorno al 45-50%. Ma nella seconda metà del Novecento, e tantomeno
nei decenni a cavallo del cambio di secolo, non si è più assistito,
praticamente in tutti i paesi ricchi del mondo, ad un ricorso
significativamente consistente e con carattere di continuità basato su
imposizioni progressive sulle ricchezze accumulate. La questione rimasta
irrisolta si presenta pertanto come un tema centrale per la lotta delle
disuguaglianze nel XXI secolo, e come tale verrà ripresa da P.
nella Parte Quarta. Nel corso degli anni Novanta, per motivi connessi alla
concorrenza fiscale tra paesi e alla vincente ideologia neo-liberista buona
parte di queste imposte sono state semplicemente abolite. Sul piano quindi
della reale capacità di incidere sulla struttura delle disuguaglianze le
società socialdemocratiche, nel senso ampio del termine qui utilizzato, non
hanno quindi ottenuto risultati sufficientemente significativi, ma soprattutto
stabilmente fondati, tali da reggere l’urto dirompente delle ideologie che a
partire dagli anni Ottanta si sono mosse al loro attacco. E’ il tema che P. affronterà nel successivo Capitolo 13. Per intanto nel prossimo
Capitolo 12 verranno esaminate le società comuniste, e post-comuniste, ossia
l’altro percorso storico di uscita dalla società dei proprietari
Capitolo 12
Le società comuniste e
post-comuniste
(In cui P. dopo aver analizzato i
limiti delle esperienze socialdemocratiche esamina la seconda forma di società subentrata alla società dei
proprietari in alternativa concorrenziale con quella socialdemocratica: quella
comunista e post comunista
E’ possibile
prendere il potere senza aderire a una teoria della proprietà?
Studiare
l’esperienza del comunismo sovietico significa cercare di capire le ragioni di
un drammatico fallimento che P. non misura da un punto di vista politico ma nella sua reale
capacità di incidere, in modo efficace e duraturo, sulla struttura delle
disuguaglianze e, al tempo stesso, nella sua universale valenza ideologica.
All’indomani della Rivoluzione di Ottobre, avvenuta come è noto sull’onda di
avvenimenti eccezionali, era stato quasi automatico proclamare l’abolizione
della proprietà privata, in teoria quindi la massima uguaglianza possibile, ma
da subito si è rivelato molto più complesso costruire dal nulla
un’organizzazione alternativa della società. Nel confuso periodo post
rivoluzionario alcune correnti bolsceviche, e probabilmente lo stesso Lenin,
ritenevano che la NEP, Nuova Politica Economica, potesse avere come obiettivo
di lungo periodo, superate le prime temperie, una forma strettamente
regolamentata di economia di mercato, comprensiva quindi anche di limitati
spazi per la proprietà privata, ma l’avvento al potere di Stalin sancì, a
partire dal 1928 ed in via definitiva con il prevalere del ruolo del Partito
Comunista come fulcro del potere statale, di impostare la struttura economica russa
sulla collettivizzazione dell’agricoltura e sulla statalizzazione di tutte le
forme di produzione e di proprietà. In un paese in cui l’industrializzazione
era ancora agli albori e in agricoltura la servitù della gleba era un retaggio
ancora recente l’abolizione dell’iniziativa privata aveva su questi settori una
ricaduta tutto sommato gestibile, ma colpiva in modo dirompente la vasta parte
della popolazione dedita all’artigianato, al commercio ed ai piccoli servizi.
La storia del trentennio che va dalla Rivoluzione al secondo dopoguerra
racconta, come conseguenza tanto inevitabile quanto feroce, una pesante
costrizione da parte del regime su questi ceti sociali, basti pensare che
ancora alla morte di Stalin, nel 1953, oltre il 5% della popolazione adulta era
in carcere per “furto di proprietà socialista”, in realtà piccoli reati
commessi nella gestione di queste attività collaterali. La realizzazione di
questa idea di economia statalizzata fortemente centralizzata sotto la
direzione del Partito non si è però basata sulla sola capacità repressiva,
perché oggettivamente è stata in grado di coinvolgere in modo persuasivo,
rafforzato dal ricordo sempre vivo del tragico regime zarista, la maggioranza
del popolo sovietico presentandosi come un progetto ideologico di utopico
radicale cambiamento. Va riconosciuto che, proprio grazie a questo forte
coinvolgimento della stragrande maggioranza della popolazione, nei decenni dal
1920 al 1950 il connubio fra ideali sociali e concrete politiche economiche è
stato in grado di realizzare una straordinaria modernizzazione del paese capace
di colmare il secolare ritardo rispetto all’Europa occidentale. E’ questo, in
estrema sintesi, lo sfondo storico sul quale poggiare le valutazioni di merito
sulla evoluzione storica della struttura della disuguaglianza che, sulla base
dei dati disponibili purtroppo per quella sovietica scarsi e frammentari, può
essere sintetizzata in questo grafico che confronta le
curve della quota di reddito nazionale detenuta dal decile superiore della popolazione
in Russia, in Europa e negli USA nel periodo 1900 – 2010
Grafico 50
L’evoluzione
della ricchezza detenuta dal decile superiore in Unione Sovietica ha un
visibile andamento caratterizzato dal rapido crollo nel tormentato periodo
prerivoluzionario, seguito da un andamento costante per tutto il periodo
sovietico e da un successivo balzo verso l’alto, ad URSS implosa, fino a
superare i livelli statunitensi già del loro molto elevati. E’ però
fondamentale chiarire che il dato del periodo sovietico, 1920-1980, non è
costituito dalla sola componente monetaria, la quale da sola avrebbe
determinato percentuali decisamente più basse – la gerarchia salariale è stata
infatti lungo tutto questo periodo decisamente contenuta - ma, affinché il
confronto con USA ed Europa poggi su basi più omogenee, per P. è stato necessario
includere anche le rilevanti integrazioni al salario, sotto forma di
“benefit” e di accesso privilegiato a
determinati servizi, concesse alle figure sociali che componevano l’articolato
decile superiore russo (élite politiche, tecnici di alto livello, direzioni
produttive). La cui percentuale media di ricchezza detenuta non si è mai
comunque discostata, se non per limitate variazioni congiunturali, dal 25% del
reddito nazionale. Sembrerebbe emergere quindi un contenuto livello di
disuguaglianza ma, se determinato su queste basi, non così più basso dei
livelli raggiunti, nello stesso periodo, in Europa, ed in particolare nei paesi
dell’area nordica, così come si può rilevare dai precedenti grafici 34 e 35.
Si deve infatti considerare, anche in questo caso sulla base di dati di
non automatica comparazione, che il tenore di vita medio nel periodo in esame,
partito nel 1920 da un livello pari al 35% rispetto a quello medio occidentale,
è progressivamente cresciuto in modo importante ma senza mai superare la quota
del 65%, come dimostra il seguente grafico relativo al
rapporto tra il reddito medio in Russia ed Europa nel periodo 1900 – 2010. Questo
significa che in termini assoluti di comparazione anche il 25% mediamente
posseduto dal decile superiore sovietico non ha mai rappresentato un identico
tenore di vita rispetto a quello occidentale e quindi una ricchezza da reddito
di effettivo pari valore
Grafico 51
Si nota
infatti come la crescita di questo rapporto sia avvenuta in buona misura nel
periodo 1920–1950 per poi arrestarsi e stagnare attorno al 60-65% fino al 1980
e quindi riprendere a risalire dopo la fine dell’URSS. Per meglio comprendere
questo andamento è necessario considerare che uno dei maggiori pregi del regime
sovietico è consistito nel massiccio investimento sull’istruzione, che in URSS
ha effettivamente raggiunto, ed in alcuni campi superato, il livello
occidentale, un fattore che, come si è visto, teoricamente può, grazie al
possibile correlato aumento di produttività, incidere in misura decisiva sulla
ricchezza da reddito. Ricaduta che non pare essersi realizzata in URSS,
addirittura entrata a partire dagli anni Sessanta in regime di stagnazione, e
la spiegazione di questa contraddizione non può che consistere nella scadente
organizzazione del sistema produttivo fortemente centralizzata e mirata ad
obiettivi più politici che economici. E’ quanto, superata la baldanzosa fase
storica di avvio del comunismo, lasciata alle spalle la grande spinta connessa
allo sforzo bellico del secondo conflitto ed avviata una “normalità” economica,
si è verificato per l’esperienza sovietica. La quale, raggiunti i suoi massimi
livelli nell’immediato dopoguerra, ha da lì in poi iniziato a dare evidenti, e
mai più recuperati, segnali di stasi e di regressione con la conseguente
ricaduta sul tenore di vita che, in colpevole aggiunta, si è sempre più
manifestato, a partire dal 1950/1960, proprio in coincidenza con l’opposta
esplosione del consumismo di massa occidentale. In un quadro che, riprendendo
la considerazione con la quale P. ha aperto questo Capitolo, già del suo dimostrava quanto sia
complesso costruire una idea alternativa di società, la guerra fredda ha poi
comportato un ulteriore pesante aggravio: le ipertrofiche spese militari,
comprensive di quelle per la concorrenza spaziale, sono arrivate a costituire
il 20% del prodotto interno lordo rispetto al 5-7% negli USA. Ma mentre questa
voce di spesa statale ha rappresentato per l’Occidente un importante incentivo
per la crescita economica, nell’URSS tale ricaduta non solo non si è realizzata
ma ha al contrario impedito altri più efficaci investimenti, ad ulteriore
conferma del fallimento dell’organizzazione sovietica dell’economia. Va poi
aggiunto che tale realizzazione non pare aver neppure sedimentato una
significativa eredità ideologica: il crollo del regime sovietico è stato
non a caso seguito da un frenetico e
incontrastato affermarsi delle più ciniche logiche di mercato che, come i due
precedenti grafici 50 e 51 raccontano, hanno nel
giro di un solo decennio visto formarsi una Russia in cui la curva del reddito
medio non è cresciuta più di tanto, mentre quella della quota di ricchezza del
decile superiore è rapidamente schizzata verso l’alto a ricreare un livello di
disuguaglianze fra i più alti nel mondo. Questo contraddittorio percorso
storico non poteva non avere una diretta conseguenza sulla stessa capacità
attrattiva dell’ideologia alla sua base, il fallimento della concreta
esperienza sociale, economica e politica si è infatti accompagnato a quello
parallelo dell’influenza ideologica del modello sovietico nel resto del mondo.
In un eventuale grafico anche questa curva disegnerebbe una indubbia crescita
fino ai primissimi decenni del secondo dopoguerra per poi declinare tanto
rapidamente quanto irreversibilmente. I fattori specifici che possono spiegare
questo declino sono molti, a partire dalla ingiustificabile morsa di ferro con
la quale sono stati gestiti i rapporti con i paesi “satelliti”, soprattutto
quelli europei, ma ha sicuramente inciso, ben oltre le problematiche economiche
e sociali, lo “svuotamento interno” di molti dei cavalli di battaglia che a
lungo avevano testimoniato la bontà ideologica sovietica esercitando una
profonda e diffusa influenza tanto in Occidente
quanto nelle vaste aree del mondo che nell’immediato secondo dopoguerra
stavano uscendo dal dramma delle dominazioni coloniali. Uno fra i tanti, il
peso della donna nella gestione della società: per tutta la fase fino al 1950
nelle istituzioni politiche sovietiche le donne ricoprivano un buon 40% dei
posti, a testimoniare un significativo coinvolgimento paritario, nel decennio
1960-1970, proprio mentre in Occidente esplodeva il movimento femminista, tale
percentuale crollava a meno del 10%. Tutte le considerazioni sin qui svolte
attestano l’incapacità dell’esperienza del comunismo sovietico di creare un
modello di società, adeguatamente sostenuto da una sedimentata e condivisa
ideologia, capace di tradursi in una concreta realizzazione sufficientemente
vincente sui tempi lunghi. E di conseguenza in grado di determinare, per quanto
riguarda la ricchezza prodotta, il reddito, una diversa struttura delle
disuguaglianze stabile e irreversibile. Se è impossibile negare questo verdetto
storico resta utile per P. approfondire le ragioni che, per quanto concerne la disuguaglianze
di ricchezza posseduta, hanno indotto il potere sovietico ad assumere una
posizione così radicale nei confronti di qualsiasi forma di proprietà privata,
compresa quella dei mezzi di produzione di piccole e piccolissime dimensioni.
Una prima ragione consiste proprio in un eccesso di esaltazione ideologica del
“diritto alla proprietà” seppure in chiave negativa. Se l’ideologia
proprietaristica fa della sacralità della proprietà un valore tale da non
consentirne alcuna incrinatura, allo stesso modo, in una prospettiva capovolta,
il comunismo sovietico ha visto nel diritto alla proprietà il nemico per
eccellenza al quale non va concesso il minimo spazio nell’identico timore che
una seppure timida concessione apra la breccia. Ha inoltre inciso una seconda
visione ideologica: l’idea di una umanità di “uguali” così potentemente
pervasiva da non consentire percorsi individuali, di qualsiasi genere, non
riconducibili all’identità unificante ed unificata dal comunismo e dalla
comunanza dei bisogni elementari. E’ chiaro che in una visione così ferrea ogni
iniziativa individuale, a partire da quelle economiche per quanto di scarso
valore, non poteva non essere vista come un esempio negativo da evitare ad ogni
costo. Non è da escludere che questi due granitici presupposti ideologici
potessero essere declinati con un certo grado di apertura, come quella già
richiamata in precedenza della NEP leninista, ma l’impatto dirompente del
“socialismo in un solo paese” accerchiato dai nemici di classe, specie nella
sua declinazione stalinista, ha poi di fatto impedito ogni minima tolleranza.
L’insostenibilità storica di una visione ideologica così rigida non poteva non
sfociare in un reazione opposta e contraria non appena il sistema sociale
sovietico non ha più retto alla sfida del tempo e dei tempi. Ed in effetti la
fragilità della costruzione comunista è stata ancor più evidenziata dalla
deriva oligarchica e dal vero e proprio saccheggio dei beni pubblici avvenuto
negli anni immediatamente successivi alla fine dell’URSS. La Russia di Eltsin
prima e di Putin poi ha messa da subito in atto una sorta di “terapia d’urto”
privatizzando la quasi totalità delle proprietà pubbliche, anche mediante un
sistema di “voucher”, una sorta di “buono di privatizzazione”, di parcellizzato
titolo di proprietà di imprese pubbliche, consegnato a buona parte della
popolazione. Peccato però che nel contesto di iperinflazione(2.500%!!!)
nell’immediato dopo comunismo, questi voucher siano stati rastrellati a valore
svenduto da pochi ed abili azionisti rapidamente divenuti i nuovi “oligarchi”
del paese. In pochi anni la rivista Forbes li ha sanciti in testa alla
classifiche dei miliardari di ogni categoria! Una classe di superricchi (vedi
il grafico 50 per la ricchezza da reddito, per
quella patrimoniale si veda il successivo grafico 55)
oltretutto protetta e coccolata dal potere: in Russia non esiste imposta
progressiva sul reddito, non esiste tassazione sulle eredità, e non si trova
traccia di una seria anagrafe delle ricchezze patrimoniali. Un percorso tutt’altro
che scontato: la fine del regime comunista poteva, in teoria, aprire la strada
ad una correzione della società in forma “socialdemocratica”, ma il timore,
condiviso a livello internazionale e concretizzatosi in fortissime pressioni e
ricatti, di lasciare margini ad un qualche ritorno al comunismo, ha azzerato
tale prospettiva imponendo una struttura sociale totalmente verticale fondata
su gerarchie rigide e su un autoritario controllo personale del potere.
La Cina:
un’economia mista autoritaria
L’altro paese
comunista per eccellenza, la Cina, ha fatto tesoro del fallimento dell’URS e
delle contraddizioni emerse nel periodo maoista (1949-1976) per avviare dal
1978, con una serie di radicali riforme, una forma inedita di regime politico
ed economico, i cui fondamenti sono: in politica la ferrea guida del Partito
Comunista ed in economia una forma mista tra proprietà pubblica e privata.
Occorre partire da questo secondo aspetto, per capire la specificità cinese. Il seguente grafico mette a confronto il trend storico della
consistenza della proprietà pubblica in sei significativi paesi nel periodo
1978-2010
Grafico 52
Nella
definizione di “proprietà pubblica”: rientrano i beni detenuti dallo Stato, in
tutte le sua articolazioni, che possono essere immessi sul mercato, avendo
quindi un loro valore realizzabile, a formare un capitale “teorico” al netto
del debito pubblico consolidato. In parole povero rappresenta il capitale che
si potrebbe ottenere con la sua vendita a prezzi di mercato e dopo aver pagato
i debiti che gravano sullo Stato. Il dato cinese emerge come quello di gran
lunga il più alto, ma nel periodo in esame, quello dopo la svolta del 1978, è
costantemente sceso dall’iniziale 70% fino al 30% del 2006 per poi
stabilizzarsi su questo livello. La proprietà pubblica cinese, pur essendosi
quindi più che dimezzata, vale ancora al 2010 almeno tre volte tanto quella di
tutti gli altri paesi racchiusi in una forbice che va dallo 0% a meno del
10%.Tenendo conto che il 40% della proprietà pubblica cinese passata in mani
private è costituito in grandissima prevalenza da immobili residenziali e che
nelle mani pubbliche, a comporre il restante 30%, concorre il possesso del 60%
delle imprese emerge con chiarezza che il percorso seguito è stato quello di “regolarizzare”
la proprietà privata degli immobili di residenza mantenendo invece una quota
delle imprese tale da garantire un adeguato controllo del sistema produttivo da
parte dello Stato. Lo si può bene cogliere con il
seguente grafico che mostra l’evoluzione della proprietà di imprese cinesi
sempre nel periodo 1978 – 2010
Grafico 53
E’ questa la
prima componente che precisa l’idea di “economia mista” cinese. Il grafico 52 evidenzia inoltre che in tutte le altre
economie la significativa quota di proprietà pubblica che mediamente ancora
valeva dal 15% al 30% nel 1978 è continuamente discesa fino a una
insignificante quota molto vicina allo zero. (P. riprenderà
questo dato, con le dinamiche che lo sottendono, e la sua stretta relazione con
il debito pubblico nel successivo Capitolo 13, vale la pena di anticipare il
dato italiano: nel 2010 l’Italia è il solo paese tra quelli “sviluppati” ad
avere un debito pubblico superiore al capitale pubblico).
Tornando alla specifico cinese un altro importante dato va tenuto nella giusta
considerazione: la proprietà dei terreni agricoli. Già prima delle riforme del
1978 una buona parte dei terreni agricoli, quasi tutti di limitate estensioni a
conduzione familiare, era di proprietà privata in quanto requisito
indispensabile per la condizione di “residenza rurale”. Lo straordinario
sviluppo degli ultimi decenni del secolo scorso ha, come è noto, accelerato a
dismisura il fenomeno dell’inurbamento, ma la condizione di “residenza urbana”,
necessaria per accedere a certe scuole e servizi, è riconosciuta solo a fronte
della rinuncia alla “residenza agricola” tramite la cessione dei terreni
posseduti a titolo gratuito allo Stato, il quale provvede poi a riassegnarli ad
altri soggetti. Si tratta quindi di una forma di proprietà “intermedia”
flessibile e in continuo mutamento. Quali sono le ricadute sulla struttura
delle disuguaglianze cinesi della “economia mista” così come si è venuta
conformando dal 1978? Il seguente grafico mette a
confronto il dato cinese della quota di ricchezza posseduta dal decile
superiore e dal 50% della popolazione più povero con quello analogo degli USA e
dell’Europa.
Grafico 54
Anche se per
la Cina non è facile il reperimento di dati di buona affidabilità il quadro che
emerge è sicuramente indicativo: la forbice fra la ricchezza, da reddito,
detenuta dal decile superiore e dal 50% più povero si è allargata in tutte le
tre situazioni in esame, ma mentre per l’Europa il divario è cresciuto in modo
più contenuto e per gli USA si è al contrario assistito ad una impressionante
accentuazione, la situazione cinese si è evoluta con una curva intermedia più
vicina a quella americana che a quella europea. Un dato che per un paese
“comunista” non può non rappresentare una evidente contraddizione; l’economia
mista cinese, con la crescita della proprietà privata evidenziata dai
precedenti grafici 52 e 53, ha prodotto una
struttura delle disuguaglianze molto simile a quella del turbocapitalismo
statunitense. Non dissimile pare essere la situazione
della ricchezza patrimoniale posseduta dal decile superiore cinese
consolidatasi in pochi decenni così come dimostra il seguente grafico
Grafico 55
Le riforme
avviate nel 1978 erano deliberatamente mirate ad ampliare i margini della
proprietà privata, in buona misura costituita da piccoli appezzamenti agricoli
a conduzione familiare, che al tempo era pari al 30% della ricchezza totale
cinese. La quota parte di questo 30% detenuta dal decile superiore era,
mancando dati certi al riguardo, presumibilmente calcolabile al massimo in un
20%. Nel giro di soli tre decenni, sulla base di dati già più consolidati, il
decile superiore è passato a detenere il 65% di tutta la ricchezza patrimoniale
privata cinese, un dato molto prossimo a quello statunitense e della Russia
oligarchica. Si deve poi tenere conto di una importante specificità: questa
ricchezza è costituita quasi esclusivamente dalle voci che compongono la
“ricchezza urbana” essendo quella del resto della popolazione ancora costituita
da piccoli possedimenti agricoli. Vale a dire che la ricchezza patrimoniale del
decile superiore è interamente frutto della impressionante crescita
dell’economia cinese, quella commerciale, produttiva, tecnologica, immobiliare,
azionaria. Questo quadro sembra aver raggiunto una sua qualche stabilità
nell’ultimo decennio, ma va ancora precisato che al momento in Cina non esiste
alcuna imposta sulle successioni e che quindi tale ricchezza se, al momento,
non pare più crescere con la stessa intensità è, salvo improvvise inversioni di
rotta politica, destinata comunque a consolidarsi e persino a divenire
attrattiva per lo spostamento in Cina, vale a dire in prima battuta ad Hong
Kong, di ricchezze finanziarie straniere. Come si concilia questa indubitabile
crescita delle disuguaglianze cinesi con il rigore ideologico di un regime che
non rinuncia a definirsi comunista? Per capirlo P. prende
in esame gli scritti teorici del presidente Xi Jinping, il cui nome figura nel
preambolo della Costituzione cinese dopo quelli di Mao Zedond e di Deng
Xiaoping a testimoniare un suo pieno riconoscimento di guida suprema. Nella pagine dedicate a definire il
“socialismo con caratteristiche cinesi” non si fa cenno di fiscalità
progressiva piuttosto che di cogestioni, ma abbondano i passaggi in cui si
afferma che la “mano invisibile del mercato”, contesto ormai dato per
acquisito, deve essere equilibrata dalla “mano visibile del partito”, del
governo, per evitare abusi e degenerazioni. Ed in effetti alcuni sporadici casi
di condanne per eccessi di profitto non regolamentare si sono verificati, ma i
dati evidenziati sembrano dimostrare un’idea molto elastica di abusi e
degenerazioni. D’altronde lo stesso partito comunista cinese, il custode
dell’ideologia che guida il paese, non appare essere così compatto ed omogeneo
nel difendere i valori alla sua base. Pesa ancora, a giudizio di P.,
l’eredità lasciata dal furore ideologico della Rivoluzione Culturale. Ampi
strati della stessa classe dirigente cinese sono figli di una generazione
terribilmente vessata in ogni aspetto, non solo economico, di possibile
individualismo. E quindi anche all’interno del partito comunista non manca,
come forma di reazione, una certa accondiscendenza a logiche di accumulazione.
Un romanzo dello scrittore Yu Hua con titolo “Brothers” descrive molto bene
questa contraddittoria fase di transizione ideologica, attraverso il racconto
degli opposti percorsi di due fratelli, uno ancora ligio alla pura tradizione
comunista e l’altro invece così abile a sfruttare il nuovo corso da divenire un
ricco miliardario. La solidità della direzione comunista sembra paradossalmente
poggiare più che su chiare visioni interne sul diffuso convinto rifiuto delle
democrazie elettorali occidentali incapaci di garantire, con l’alternarsi di
elezioni e governi, un efficace e coinvolgente dibattito politico, come quello
che avviene nel PCC all’insegna della “democrazia controllata”, capace di
produrre politiche realmente condivise. Ma resta evidente che l’esperienza
cinese dell’economia mista è un processo ancora in piena evoluzione con esiti
tutt’altro che definiti
L’Europa
orientale: un laboratorio della disillusione post-comunista
L’influenza
comunista sui paesi dell’Europa orientale entrati dopo il secondo conflitto
nell’orbita dell’URSS si è fatta sentire per un periodo storico di pochi
decenni ma, congiuntamente con i processi che si sono innestati successivamente
al crollo del muro di Berlino, comunque rilevante e tale da aver non poco
influito sulla loro attuale struttura delle disuguaglianze. Anche in questo
caso l’attenzione di P. è concentrata su questo specifico aspetto e, accomunando in un
unico blocco realtà nazionali ed etniche tutt’altro che omogenee, non entra più
di tanto nel merito delle molte collegate tematiche di vario ordine. Il comune
dato geopolitico consiste nella loro totale adesione all’Unione Europea
avvenuta nell’ambito di un processo tutt’altro che lineare e non privo di
stridenti contraddizioni. Il controllo sovietico, solo in minima parte
coniugato ad una autonoma adesione all’ideologia comunista e oltretutto
avvenuto nella fase già discendente del comunismo russo evidenziata in precedenza,
ha di fatto bloccato nei primi decenni del secondo dopoguerra lo sviluppo
economico e la crescita dei rispettivi redditi nazionali, determinando un
livello di disuguaglianza molto simile a quello della Russia sovietica. Da
questa iniziale situazione di arretratezza economica, ma coniugata con un basso
livello di disuguaglianza, inizia, dai primi anni Ottanta, un percorso con
evidenti chiaroscuri. Il seguente grafico lo evidenzia
mettendo a confronto le curve di crescita della ricchezza da reddito detenuta
dal decile superiore e dal 50% più povero per tre macro aree: USA – Europa
Ovest – Europa Ovest + Est nel periodo 1980-2010:
Grafico 56
Tutte le
curve rappresentate nel grafico hanno un analogo andamento: la forbice della
differenza fra la quota di ricchezza detenuta dal decile superiore e quella del
50% più povero tende ad accentuarsi in modo significativo. Quella statunitense,
già più ampia nel 1980, si allarga tantissimo, mentre le due europee, già molto
simili in partenza, mantengono una progressione tutto sommato analoga e di
molto inferiore a quella americana, con una leggera maggiore ampiezza di
divario per quella dell’Europa Ovest+Est. E’ quindi possibile sostenere che la
curva delle disuguaglianze nei paesi ex-comunisti dell’Europa dell’Est non è
esplosa verso l’alto così come nella Russia degli oligarchi (grafico 50). Hanno concorso a questo contenimento due
fattori fra di loro concatenati: da una parte il permanere di sistemi di
istruzione e di protezione sociali eredità del periodo comunista
paradossalmente meglio mantenuti che nella stessa Russia e dall’altra
l’influenza degli indirizzi politici ed economici della UE e della parte
occidentale europea. Un livello di disuguaglianza più contenuto e simile a
quello medio dell’Europa Ovest quindi, anche se è corretto relazionarlo ad un
livello di reddito medio ancora inferiore, quello dei paesi dell’Europa
orientale che ancora nel 1990 valeva solo il 45% di quello occidentale è salito
a circa il 65-70% nel 2010, con uno scarto quindi ancora significativo.
L’insieme di questi dati sembrerebbe attestare che “l’ombrello UE” ha
rappresentato un punto di appoggio fondamentale nella fase post-comunista. Un
aspetto che è confermato dal seguente grafico che
evidenzia per quattro significativi paesi dell’Europa dell’Est i flussi in
entrata dalla UE (finanziamenti europei, al netto delle quote versate, e
investimenti privati) ed in uscita verso la UE (profitti e altri redditi in
capo ad investitori europei) rilevati a cavallo del 2010 ed espressi in % del loro
PIL
Grafico 57
Se da una
parte il flusso degli investimenti e dei contributi UE vale in media dal 2% al
4% del PIL dall’altra quello dei profitti e dei ricavi che tornano verso i
paesi investitori europei sta in un range che va dal 4% a più del 7%. Se quindi
da una parte il sostegno europeo ha contribuito in modo significativo alla
crescita del reddito medio, ed al contenimento delle disuguaglianze, dall’altra
appare evidente che questo apporto, nelle logiche di mercato, ha comportato un
ritorno importante in termini di profitto verso l’estero. Questa situazione ha
contribuito non poco a rafforzare la diffusa percezione che le potenze
economiche della UE vedano i paesi ex-comunisti come una fonte di guadagno, ed
è vero che mediamente gli investitori stranieri detengono un quarto del loro
capitale, e che quindi li trattino come cittadini di serie B buoni a costituire
un serbatoio di manodopera a buon mercato. Un sentire diffuso che si coniuga
inoltre con una comune forte identità etnica di stampo tradizionalista e di
chiusura nazionalistica. L’insieme di questi sentimenti è alla base di una
sorta di disillusione che spiega al contempo il rifiuto di ogni proposta
ideologica e politica che in qualche modo sia assimilabile a ideali socialisti
e socialdemocratici e l’affermarsi di una specifica ideologia
“social-nativista”, ossia una visione della società sostanzialmente
conservatrice e etnicamente orientata verso una netta chiusura. Difficile al
momento immaginare la futura evoluzione di queste società sia in termini
ideologici che per quanto concerne la struttura delle disuguaglianze, al
momento ambedue ancora troppo condizionate dalla volontà di chiudere
definitivamente i conti l’eredità della parentesi comunista e dalla
contemporanea diffidenza verso la sacralizzazione occidentale del mercato.
Capitolo 13
L’ipercapitalismo: tra modernità
ed arcadia
(In cui P. conclude la panoramica
della “grande trasformazione del XX secolo”
analizzando le caratteristiche della radicale evoluzione delle
disuguaglianze avvenuta negli ultimi decenni del secolo, conseguenza dei limiti
delle società socialdemocratiche, del fallimento di quelle comuniste, e
dell’affermarsi globale del neo-liberismo. Completando così il quadro sul quale
inserire le proposte di uscita che analizzerà nella seguente Parte Quarta
Le forme
della disuguaglianza nel mondo nel XXI secolo
Nei Capitoli
precedenti si sono analizzate le ideologie che hanno sostenuto le forme di
società, e le loro specifiche strutture delle disuguaglianze, subentrate nel
corso del XX secolo alla società dei proprietari che aveva caratterizzato
l’intero secolo precedente. In ogni percorso preso in esame si è anche visto
che gli ultimi due decenni del Novecento segnano in qualche modo una netta
cesura collegata all’indubbia affermazione della globalizzazione neoliberista
ed alla svolta tecnologica della digitalizzazione e delle Rete. Per meglio
comprendere le sfide che una migliore e più diffusa giustizia sociale dovrà
affrontare nel corso del XXI secolo è necessario iniziare a fissare alcune
delle caratteristiche di questo nuovo quadro mondiale del regime delle
disuguaglianze, che vanno in primo luogo relazionate ad una impressionante e
diseguale crescita demografica. Il seguente grafico la
evidenzia con le curve della crescita, in miliardi di abitanti, già avvenuta
nei diversi continenti dal 1700 ad oggi e completata con quella prevista da qui
al 2050.
Grafico 58
In un pianeta
dalle risorse limitate una popolazione mondiale di più di nove miliardi di
persone rende ancor più ambizioso, ma al tempo stesso davvero molto complicato,
l’immaginare un adeguato livello diffuso di uguaglianza. Anche perché si parte
da una situazione che al momento vede al contrario una distribuzione della
ricchezza molto disomogenea con conseguenti livelli di disuguaglianza
altrettanto differenziati come dimostra il seguente
grafico che fotografa la quota di reddito totale detenuta nel 2018 dal decile
superiore in nove situazioni rappresentative del quadro generale
Grafico 59
E’ evidente
la disparità di situazioni, in una scala a salire si va dal 33% del dato
europeo, il più basso in assoluto, a quelli clamorosamente più alti, mediamente
il doppio, del M.O., del Sudafrica e del Quatar con ben il 69%. Non diversa è
la situazione se si passa a considerare con il
successivo grafico la ripartizione del reddito totale, sempre al 2018, fra il
decile superiore, il 40% intermedio ed il 50% più povero nelle tre aree più
indicative
Grafico 60
Ancora una
volta l’Europa si rivela la più egualitaria e quella con la maggiore incidenza
della classe media, mentre invece, con gli USA in una situazione intermedia, il
M.O. è l’area con la più accentuata disuguaglianza. Il seguente
grafico visualizza in modo ancor più impattante la differenza del rapporto fra
la quota del reddito posseduta, sempre al 2018, dal 50% più povero con quella del
centile superiore ossia l’1% più ricco per quattro macro aree
Grafico 61
Sono evidenti
le differenze del livello di disuguaglianza nel mondo al 2018, ed è importante
sottolineare che queste situazioni si sono determinate nell’arco ristretto dei
decenni a cavallo del cambio di secolo e che vedono tuttora una loro costante
accentuazione. Il precedente grafico 59 attesta
poi che le regioni del mondo in cui si registrano le più alte disuguaglianze
corrispondono, non a caso, a regimi politico-ideologico che sostengono visioni
di disparità di status, di discriminazione razziale, di residui coloniali se
non di vera e propria schiavitù. Questa indubbia consistente ripresa delle
disuguaglianze deve essere collegata non solo al complesso quadro demografico
visto in precedenza ma anche alla drammatica situazione ambientale e climatica.
Se sono evidenti le sue ricadute sull’intera umanità, e sull’intero pianeta,
non è però semplice determinare in modo adeguato quelle sull’economia, sulla
società, e sulla struttura delle disuguaglianze. I parametri normalmente utilizzati
rischiano non solo di essere inadeguati ma addirittura fuorvianti. Il primo
parametro insoddisfacente da questo punto di vita è il PIL. Non a caso in tutti
grafici del saggio P. utilizza al suo posto la nozione di “reddito nazionale”, ossia il
dato del PIL decurtato del deprezzamento del capitale e bilanciato con il
flusso dei redditi in entrata ed uscita con l’estero. Questa nozione consente,
per tornare all’incidenza dell’emergenza ambientale e climatica, anche di
meglio valutare le sue possibili ricadute: ad esempio un paese impegnato con
notevoli investimenti a rimediare ad ingenti danni ambientali ha una ricaduta
importante sul PIL, ma al tempo stesso ha subito una evidente decurtazione del
suo capitale reale. Va inoltre aggiunto che al momento i modelli matematici
applicati all’economia non tengono adeguatamente conto del consumo di capitale
naturale, ad esempio l’industria mineraria ed estrattiva genera PIL ma consuma
una risorsa naturale, una perdita di valore che però non viene conteggiata. Alcuni
studi hanno valutato in una quota che va dal 5% al 20% del PIL mondiale
l’impatto complessivo dell’ambiente sull’economia non rilevato dal solo PIL.
Non solo: esiste una evidente “disuguaglianza ambientale” per i danni
all’ambiente sia causati che subiti. Le emissioni di CO2
in primis non implicano pari responsabilità per tutti i paesi, se si valutano
quelle emesse direttamente (produzione, trasporti interni, riscaldamento, etc.)
e indirettamente (quelle emesse per produrre e trasportare, in quota parte, le
merci importate/esportate) si ha un quadro globale fortemente diseguale. Il seguente grafico evidenzia la quota in % di CO2 emessa, nel periodo 2010-2018, per quattro macro-aree
mondiali: la prima pila indica la % di CO2, diretta e indiretta, la seconda pila la % emessa solo
direttamente, quella più determinata dai consumi interni
Grafico 62
L’alta
percentuale di emissioni statunitensi è sicuramente attribuibile al grande
divario di reddito ed ai collegati stili di vita molto energivori, la stessa
considerazione, anche se in misura ridotta, vale per l’Europa, mentre Cina e
Resto del mondo hanno percentuali di emissione diretta inferiori a quelle
calcolate considerando anche quelle indirette, a testimoniare il peso della
“disuguaglianza ambientale”. Tornando a quelle economiche i grafici 59-60-61 ne hanno evidenziato la crescita
esaminando dati relativi alla ricchezza da
reddito, ma non dissimile è quella della ricchezza patrimoniale come si
può evincere dal seguente grafico che traccia le curve
della crescita della quota di proprietà in capo al decile superiore in sei
paesi rappresentativi della tendenza globale 1900-2010
Grafico 63
Ancora una
volta P.
ripropone, giudicandola fondamentale, una panoramica sul lungo periodo
dell’andamento delle disuguaglianze, in questo caso quelle relative alla
ricchezza patrimoniale posseduta dal 10% più ricco, per evidenziare sia
l’importante contrazione avvenuta per buona parte del XX secolo sia
l’improvvisa, e accelerata, risalita avvenuta ovunque a partire dal 1980.
Occorre inoltre tenere nella giusta considerazione che questi dati
rappresentano la realtà “per difetto”, sono infatti molto consistenti le forme
di ricchezza patrimoniale che, nell’era dei big data!, sfuggono ad un più
accurato censimento: sono quasi ovunque molto opachi i catasti finanziari,
sottostimati quelli immobiliari per lo più riferiti a valori teorici molto
inferiori a quelli di mercato, per non dire poi dell’ancora intatto ruolo dei
paradisi fiscali. Al punto da rendere sostenibile una integrazione dei dati
ufficiali, sui quali è costruito il grafico 63,
con quelli reperibili in una fonte particolare: le classifiche dei patrimoni
mondiali regolarmente stilata ogni anno dalla rivista americana Forbes, la
quale attesta un tasso annuale di crescita dei
patrimoni più ingenti dell’ordine del 6-7% (al netto dell’inflazione) nel
periodo 1987-2017 come evidenzia la seguente tabella 4 costruita proprio sui
dati Forbes:
Tabella 4
Si coglie
bene la differenza della progressione: i patrimoni nel mondo sono cresciuti ad
un tasso annuale molto più alto di quello della crescita del PIL o reddito
totale, per il centomilionesimo più ricco addirittura del doppio esatto. Nelle
tre aree più ricche la crescita è stata ancora più impressionante: a fronte di
un aumento inferiore del PIL i patrimoni dei più ricchi sono cresciuti anche
più del doppio. Il ritorno di una altissima concentrazione della proprietà, per
quanto difficilmente individuabile nella sua esatta consistenza, sancisce in
definitiva nei primi decenni del XXI secolo, dopo l’opposta parabola di buona
parte del XX secolo, l’affermarsi di un regime “neoproprietarista” mondiale
che, se non combattuto e governato, rischia seriamente di ricreare i livelli di
diseguaglianza registrati al culmine della società proprietaristica “classica”.
Lo evidenzia il seguente grafico che fotografa la
ripartizione della ricchezza patrimoniale fra il decile più ricco, il 40% intermedio
ed il 50% più povero nell’Europa del 1913, nell’Europa del 2018 e negli USA del
2018
Grafico 64
Anche in
questo caso l’Europa evidenzia una maggiore resistenza alla crescita della
concentrazione della ricchezza patrimoniale, a fronte di una situazione
statunitense molto vicina al picco di inizio secolo. In buona parte questa
migliore tenuta è spiegabile con la significativa quota di ricchezza detenuta
dal 40% medio. A questa fotografia del livello delle disuguaglianze di inizio
XXI secolo P. aggiunge un ulteriore importante dato: quello della
disuguaglianza di genere che si evidenzia con specifiche caratteristiche, anche
molto differenziate, in ogni singolo paese. La situazione francese può però
essere assunta come fotografia valida in generale del permanere di una
sostanziale forma di “patriarcato”. Il seguente grafico
evidenzia la percentuale di donne che rientrano nel gruppi del 50%, del 10% e
dell’1% più ricchi, relativamente alla ricchezza da reddito nel periodo
1970-2015
Grafico 65
Appare
evidente che la realizzazione di una completa uguaglianza di genere è ben lungi
dall’essere pienamente realizzata nonostante alcuni significativi miglioramenti
avvenuti nel corso del XX secolo soprattutto nei paesi occidentali più ricchi.
Restando alla sola disuguaglianza da reddito il grafico
65 comunque non consente repliche: più si sale la scala della ricchezza
meno consistente è la presenza femminile. Al culmine del periodo preso in
esame, nel 2015, e nonostante una costante crescita della curva, la ricchezza
da reddito che, in una situazione di piena parità, dovrebbe ripartirsi in pari
misura fra i due generi vede quella detenuta dalle donne ferma a poco più del
40% nell’ampio gruppo del 50% più ricco, per crollare al 30% ed al 15% in
quelli del 10% e dell’1% più ricchi. Se per il primo gruppo la spiegazione può
consistere in prevalenza nella differenza di trattamento salariale, per i due
gruppi più ricchi è evidente il permanere di un pregiudizio storico per
l’accesso delle donne alle posizioni più alte di responsabilità e potere. La
concentrazione verso l’alto della ricchezza da reddito evidenzia quindi una
pesante disparità di genere che si manifesta allo stesso modo anche per la
ricchezza patrimoniale là dove questa, fatta salva l’incidenza delle norme che
regolano la ripartizione ereditaria e della ricchezza familiare molto dissimili
fra paese e paese, si consolida come ovvia ricaduta sul lungo periodo delle
differenze di redditi evidenziate nel grafico 65.
A completare il quadro delle disuguaglianze all’alba del XXI secolo interviene
inoltre un preoccupante ulteriore impoverimento degli Stati più poveri a
sancire evidenti linee di una “disuguaglianza geografica”. E’ scorretta una
eccessiva generalizzazione perché il processo di formazione di ogni singolo
Stato è lungo, complesso e specifico, sono infatti molte le variabili in grado
di influenzarlo. Si deve poi tenere conto che buona parte degli Stati “poveri”
sono usciti solo nella seconda metà del Novecento dal dominio coloniale spesso
ritrovandosi privi di una minima autonoma organizzazione statale, alle prese
con notevoli pressioni demografiche, e quasi sempre comunque condizionati da
interessi esterni. Un indicatore utile a fornire un quadro di riferimento è
costituito dal gettito fiscale la cui entità può misurare sia il reddito
nazionale che la conseguente capacità di spesa, condizione base fondamentale
per attive politiche statali. Il seguente grafico
misura il gettito fiscale medio, relazionato al PIL, mettendo a confronto
quello dei paesi ricchi e dei paesi poveri, nel periodo 1970-2018, e precisando
l’incidenza al suo interno delle tasse sugli scambi internazionali
Grafico 66
Si nota che
mentre per i paesi ricchi le entrate fiscali sono mediamente salite da un
iniziale 30% al 40% quelle dei paesi poveri non si sono mai discostate da una
percentuale sul PIL di molto inferiore e pari al 15%. In molti paesi africani
queste percentuali scendono addirittura al 6-8%, ma in ogni caso sono importi
che a malapena consentono di sostenere i servizi pubblici minimi e che non sono
quindi assolutamente in grado di effettuare investimenti finalizzati ad una
reale uscita dalla povertà. Il grafico 66 consente
inoltre di rilevare che la liberalizzazione degli scambi internazionali, legata
alla globalizzazione, ha inciso in modo più consistente sui paesi poveri per i
quali questa voce negli anni settanta valeva un importante 6% del gettito
fiscale e che nel periodo in esame si è progressivamente dimezzata. L’insieme
di questi fattori non apre quindi prospettive realistiche di contenimento della
“disuguaglianza geografica”, destinata anzi, sul breve e medio periodo, ad
aumentare incentivando inoltre il drammatico fenomeno della “migrazione per
ragioni economiche”. I primi decenni del XXI secolo caratterizzati da questo
insieme di disuguaglianze - in questo Capitolo esaminate da P. in estrema sintesi allo scopo di fornire una prima iniziale
visione d’insieme, per essere meglio approfondite nella successiva Parte Quarta
– hanno poi visto il succedersi di crisi sistemiche, di cui quella del
2007/2008 è stata solo la più eclatante, indubbiamente legate alla esasperata
influenza neoliberista sull’intero ciclo economico mondiale. Uno degli
indicatori più importanti di questa influenza consiste di certo nella
finanziarizzazione dell’economia mondiale, un fenomeno di dimensioni
impressionanti con inevitabili e importanti ricadute sulla struttura delle
disuguaglianze, e che quindi sarà oggetto di specifica attenzione nella
successiva Parte Quarta. Un solo dato per dimensionarne l’impatto:
nell’Eurozona tutte le attività finanziarie che, nel loro complesso, nel 1980
già valevano la consistente quota del 300%, hanno nel 2018 superato del 1.100%
il PIL europeo. Vale a dire che in Europa esiste una ricchezza finanziaria pari
a undici annualità di PIL, una ricchezza quindi di dimensioni impressionanti ma
priva di basi reali su cui poggiare e che, paradossalmente, è cresciuta nel
periodo in esame anche grazie alla stessa massiccia immissione di liquidità
operata dalle Banche centrali proprio per fronteggiare le crisi economiche in
buona misura generate proprio dall’eccesso di finanziarizzazione dell’economia.
Anche in relazione a quest’ultimo aspetto P. individua,
anche in questo caso come prima valutazione, le narrazioni ideologiche che
sostengono il quadro delle disuguaglianze sin qui sinteticamente evidenziato.
Confluiscono in queste narrazioni diversi elementi di pensiero economico e
sociale. Centrale è sicuramente il ritorno alla “sacralizzazione” della
proprietà privata, ed il conseguente rifiuto dell’invadenza su di essa di
qualsiasi politica statale. Secondo il pensiero mainstream il ruolo della Stato
deve infatti consistere, garantendo il diritto alla proprietà, esclusivamente
nel creare e mantenere le condizioni per una concorrenza sul mercato libera e
non falsata. Lo Stato deve pertanto ritirarsi dalla gestione pubblica di servizi
e attività favorendo la loro privatizzazione totale. La fiscalità non può
quindi essere concepita come un correttivo della distribuzione di ricchezza
evitando qualsiasi ipotesi di progressività (Friedrich von Hayek, già citato in
precedenza, uno dei principali teorici del neoliberismo, sosteneva che
l’interdizione della progressività fiscale fosse inserito come principio
inamovibile nelle Costituzioni e che i redditi più alti dovessero essere
tassati ad una aliquota pari alla media dei tassi fiscali praticati sulle fasce
più povere). Ma la narrazione ideologica neoliberista non si limita alla pur
fondamentale sacralizzazione della proprietà privata, in un ritorno
all’ideologica proprietaristica ottocentesca, ma in relazione al mutato quadro
sociale introduce una ideologia meritocratica estrema. Il mercato è fatto di
vincenti e perdenti, si vince possedendo i meriti per farlo e si perde per
mancanza di meriti. Ognuno deve gareggiare, divenendo “imprenditore di sé
stesso”, per dimostrare di possedere meriti adeguati, e chi perde, e tantomeno
lo Stato, hanno il diritto di incidere sulle disuguaglianze che, correttamente,
ne derivano. Nessun dubbio quindi sul fatto che meriti e capacità possano
essere determinati da privilegi sociali preesistenti e che pertanto lo Stato
debba in qualche modo garantire pari condizioni di partenza. La crescita delle
disuguaglianze diventa in questo quadro una conseguenza fisiologica
insopprimibile ed anzi le concentrazione della ricchezza verso l’alto,
favorendo in condizioni di mercato libero la domanda, può avere ricadute
positive anche sugli strati bassi della popolazione. In tempi di Rete e social
queste narrazioni hanno trovato sponde amplificative straordinarie, fra le
altre quella dell’autentica glorificazione di imprenditori e miliardari, divisi
fra i buoni californiani innovativi ed i cattivi oligarchi russi, come se gli
uni e gli altri non godessero delle stesse favorevoli condizioni di quasi
monopolio. Rientra in questa glorificazione, a compensazione dello svuotamento
del ruolo dello Stato, l’ammirevole filantropia di molti di loro. “Destino” un romanzo del 2008 dello scrittore
messicano Carlos Fuentes è un efficace quadro del rampante capitalismo
neoliberista e delle figure che lo personificano


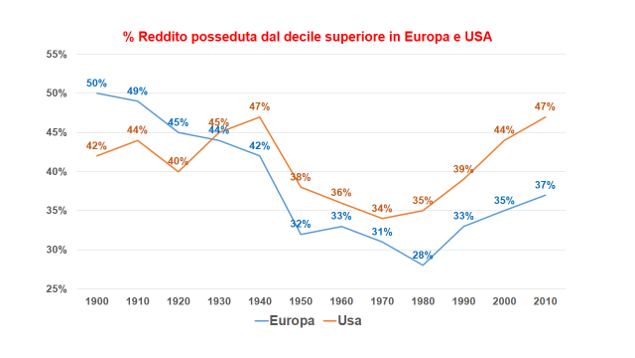


































Nessun commento:
Posta un commento